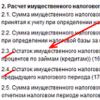Caratteristiche del sistema muscolare umano. Funzioni del sistema muscolare. Principali gruppi muscolari del corpo umano
Sistema muscolare Una persona ha circa 400 muscoli diversi, che costituiscono fino al 40% del peso corporeo. Per gli atleti, questa cifra può raggiungere il 50%. Con l'aiuto dei muscoli viene svolto il ruolo di supporto dello scheletro e del movimento umano. Promuovono una respirazione e una circolazione sanguigna più complete, sostengono gli organi interni in una determinata posizione, li proteggono dall'influenza dell'ambiente esterno, ecc. I muscoli sono altamente efficienti ed economici. Questa proprietà dei muscoli dipende direttamente dalla capacità di una persona di rilassare i muscoli inattivi. Gli atleti possiedono questa capacità in misura maggiore. Con il loro tono, i muscoli determinano in gran parte la forma e il modo di sostenere il corpo. Solo grazie al lavoro dei muscoli è possibile mantenere il corpo in posizione eretta in presenza di una piccola zona di appoggio.
I muscoli sono divisi in tre tipi: a) lisci, che ricoprono le pareti dei vasi sanguigni e degli organi interni; b) muscolo cardiaco; c) muscoli scheletrici. I primi due tipi di muscoli funzionano indipendentemente dalla volontà di una persona. Il lavoro dei muscoli scheletrici è controllato volontariamente e viene svolto a causa della tensione o della contrazione. Il muscolo scheletrico è costituito da un numero variabile di fibre muscolari.
Quando si eseguono movimenti differenziati, il numero di fibre muscolari coinvolte nel lavoro è piccolo e con l'aumentare dello sforzo muscolare il loro numero aumenta.
Ad esempio, i muscoli oculari hanno cinque fibre, mentre i muscoli del tronco e degli arti inferiori hanno fino a 200 fibre in ciascuna unità motoria. Se più di 2/3 dei muscoli scheletrici sono coinvolti in un'attività attiva, viene chiamato tale lavoro globale. Se durante il lavoro da 1/3 a 2/3 dei muscoli funzionano, allora stiamo parlando di regionale lavoro, e se inferiore a 1/3 - Locale lavoro muscolare.
Quando viene eccitato un muscolo che non cambia in lunghezza (modalità isometrica), viene eseguito un lavoro statico. La contrazione del muscolo riducendone la lunghezza (modalità isotonica) garantisce un lavoro dinamico. Molto spesso, i muscoli lavorano in modalità mista (auxotonica).
Quando i muscoli si contraggono e si tendono, sviluppano una certa forza che può essere misurata. La forza di un singolo muscolo dipende dal numero e dallo spessore delle fibre muscolari, nonché dalla sua lunghezza iniziale.
Quali muscoli sono più importanti e quali gruppi muscolari dovrebbero essere sviluppati per primi? La forza dei singoli gruppi muscolari varia da persona a persona. Le persone che non fanno esercizio tendono ad avere muscoli più sviluppati che contrastano la gravità: gli estensori della schiena e delle gambe, così come i flessori delle braccia. Negli atleti l'aumento della forza dei singoli muscoli dipende dal tipo di sport praticato. Pertanto, i sollevatori di pesi hanno gli estensori più sviluppati di braccia, gambe e busto; nelle ginnaste – i muscoli adduttori del cingolo scapolare; nei pugili: muscoli del cingolo scapolare, del collo, del torace, degli addominali, della parte anteriore della coscia; nei nuotatori: muscoli della spalla, del torace, dell'addome, muscoli laterali del busto, ecc.
Le prestazioni muscolari dipendono dal livello di circolazione sanguigna. Il numero di capillari attivi in un muscolo che lavora intensamente aumenta di 60-70 volte rispetto a un muscolo a riposo. Durante il lavoro dinamico il muscolo agisce come una “pompa” nella circolazione sanguigna. Durante il rilassamento, il muscolo si riempie di sangue e riceve ossigeno e sostanze nutritive. Quando un muscolo si contrae, il sangue e i prodotti di scarto vengono espulsi. Durante il lavoro statico, il muscolo è teso e preme continuamente sui vasi sanguigni. Non riceve né ossigeno né sostanze nutritive, ma utilizza le proprie riserve di glicogeno per ottenere energia per il lavoro. In queste condizioni, i prodotti di decomposizione non vengono rimossi e l'acido lattico si accumula nei muscoli, il che contribuisce al rapido sviluppo dell'affaticamento.
Con carichi statici, insieme ad un aumento del volume muscolare, aumenta la superficie del loro attacco alle ossa e la parte del tendine si allunga. Gli intensi processi metabolici nei muscoli contribuiscono ad un aumento del numero di capillari, formando una fitta rete, che porta all'ispessimento delle fibre muscolari.
I carichi dinamici sono inferiori a quelli statici e contribuiscono all'aumento del peso e del volume muscolare. Nei muscoli la parte muscolare si allunga e quella tendinea si accorcia. Il numero di fibre nervose nei muscoli che influenzano principalmente l'esecuzione di una funzione dinamica è 4-5 volte maggiore rispetto ai muscoli che svolgono una funzione statica.
Alcuni giovani, compresi gli studenti, sono interessati al cosiddetto. atletismo, che mira a sviluppare la forza muscolare e la definizione muscolare, utilizzando prevalentemente esercizi statici.
In effetti, tali esercizi aiutano ad aumentare il volume dei muscoli che sono in ritardo nello sviluppo, ma non sviluppano precisione, destrezza, velocità di movimento o aiutano a navigare e ad adattarsi alle mutevoli condizioni. Inoltre, richiedono un grande sforzo nervoso, rendono difficile la respirazione e limitano la capacità di sviluppare resistenza. Gli esercizi statici possono essere solo aggiuntivi a quelli dinamici e sono efficaci solo quando non superano 1/3 del numero totale di esercizi.
Il sistema scheletrico e le sue funzioni
Sistema scheletricoè costituito da più di 200 ossa collegate da articolazioni in articolazioni mobili con l'aiuto delle quali i muscoli possono lavorare. Il tessuto osseo è un organo complesso attraversato da vasi sanguigni, linfatici e fibre nervose.
Le ossa sono costituite per il 50% da acqua, la restante metà comprende sostanze organiche (12,4%) e inorganiche (21,85%), oltre a grassi (15,75%). Durante l'intero periodo di crescita, la massa dello scheletro osseo aumenta di quasi 24 volte. Quanto più giovane è l'organismo, tanto più sostanze organiche sono presenti nelle sue ossa e maggiore è l'elasticità di queste.
La parte principale del solido supporto del corpo è la colonna vertebrale, composta da 24 vertebre, l'osso sacro e il coccige. La colonna cervicale è composta da 7 vertebre, la colonna toracica da 12, la lombare da 5, la sacrale da 5 e la coccigea da 4 o 5. La colonna vertebrale ha curve naturali: cervicale e lombare lordosi, toracico e sacrale cifosi, che fungono da ammortizzatori. L'esercizio fisico aiuta a sviluppare proprietà meccaniche più elevate delle ossa. Sotto l'influenza dell'esercizio, le ossa si sviluppano, diventano più grandi, più forti e più pesanti, più ricche di calcio. La forza delle ossa, soprattutto quelle che sopportano carichi fisici pesanti, può essere vista nell'esempio del femore e della tibia. Il femore può sopportare un carico fino a 1500 kg e il secondo fino a 1800 kg. Le ossa sono collegate da articolazioni, la cui funzione principale è eseguire movimenti. Ogni articolazione è racchiusa in una capsula articolare, rinforzata dai legamenti.
Il sistema cardiovascolare
Il sistema cardiovascolare garantisce la circolazione sanguigna nel corpo. Il sangue trasporta: a) sostanze nutritive; b) ossigeno alle cellule e prodotti finali metabolici da esse; c) svolge una funzione regolatrice, effettuando il trasferimento di ormoni e altre sostanze fisiologicamente attive che colpiscono vari organi e tessuti.
Volume del sangue nel corpo sono 4-6 litri, ovvero il 7-8% del peso corporeo. A riposo, il 40-50% del sangue viene escluso dalla circolazione e si trova nei depositi sanguigni: fegato, milza, vasi cutanei, muscoli, polmoni. Se necessario, nella circolazione sanguigna viene inserito un volume di riserva di sangue.
Esiste una chiara connessione tra lo sport che una persona pratica e il volume del suo cuore. Negli uomini sani che non praticano sport il volume del cuore è in media di 760 cc; negli sciatori, mezzofondisti e nuotatori aumenta fino a 1200 cc. cm. I ginnasti hanno un volume cardiaco di 790 metri cubi. cm, boxer - 910 cc. cm. Per le atlete sono 200-300 metri cubi in meno. cm.
Il movimento del sangue attraverso i vasi avviene sotto l'influenza della differenza di pressione nelle arterie e nelle vene in circoli chiusi: grandi e piccoli. Nelle arterie, il sangue ossigenato si allontana dal cuore, mentre nelle vene il sangue gassato si muove verso il cuore. Circolazione sistemica parte dal ventricolo sinistro e termina, restituendo il sangue venoso, nell'atrio destro. Il sangue percorre un ampio cerchio in 23 secondi. Inizia dal ventricolo destro piccolo cerchio, che termina nell'atrio sinistro. Il sangue del piccolo cerchio nei polmoni è saturo di ossigeno ed emette anidride carbonica.
Il cuore è l'organo principale del sistema circolatorio, è un organo cavo costituito da due atri e due ventricoli. Il cuore è racchiuso in un sacchetto che lo protegge da uno stiramento eccessivo. Contraendosi ritmicamente, il cuore garantisce la circolazione del sangue nel corpo. Ogni contrazione ha 3 fasi: 1a fase – contrazione (sistole) degli atri – il sangue viene spinto nei ventricoli; 2a fase - sistole ventricolare - il sangue viene spinto nell'aorta (gli atri sono rilassati - diastole); La terza fase è una pausa, quando gli atri e i ventricoli riposano contemporaneamente (diastole). La durata totale del ciclo è 0,8 s: sistole – 0,39 s, diastole – 0,39 s, pausa – 0,02 s. Questa modalità di funzionamento consente al muscolo cardiaco di ripristinare l'energia spesa per la contrazione. L'eiezione ritmica del sangue nell'aorta da parte del ventricolo sinistro fa pulsare le arterie. Normale in un maschio adulto frequenza cardiaca(frequenza cardiaca) a riposo è di circa 70 battiti al minuto. Nelle donne, questa cifra è solitamente in media 2-5 battiti più alta. Il cuore di una persona allenata batte 50-60 volte al minuto, mentre per nuotatori, corridori, canottieri e sciatori può raggiungere i 35-40 battiti al minuto.
In una contrazione, il cuore spinge circa 60 ml di sangue nell'aorta. (volume sistolico), e in un minuto a riposo - circa 5 litri di sangue (volume minuto). Per un cuore allenato il volume sistolico è di circa 120 ml, e il volume minuto, all'aumentare del carico, può raggiungere i 30-40 litri. Con un carico moderato nelle persone non allenate, il crescente fabbisogno di sangue dagli organi funzionanti è assicurato principalmente a causa dell'aumento della frequenza cardiaca e nelle persone allenate - a causa dell'aumento del volume sanguigno sistolico e minuto, ad es. grazie ad una funzione miocardica più efficiente. Il più grande volume sistolico è osservato a una frequenza cardiaca da 130 a 180 battiti al minuto. A frequenze cardiache superiori a 180 battiti/min, il volume sistolico inizia a diminuire. Pertanto, il miglior effetto di allenamento si ottiene durante l'attività fisica con una frequenza cardiaca compresa tra 150 e 180 battiti al minuto.
Regolazione neuroumorale sistema circolatorio avviene indipendentemente dalla nostra volontà. Il cuore rafforza e aumenta le contrazioni quando viene stimolato il nervo simpatico, mentre rallenta e riduce la forza delle contrazioni quando viene eccitato il nervo vago. L'attività del sistema cardiovascolare (CVS) è strettamente correlata al lavoro del sistema nervoso centrale (SNC).
Per la normale circolazione sanguigna è di grande importanza pressione sanguigna, che è il risultato della pressione del sangue in movimento sulle pareti interne delle arterie e sulla colonna di sangue antistante. Distinguere massimo la pressione che si verifica quando il ventricolo sinistro si contrae, e minimo, che si verifica quando si rilassa. In un adulto a riposo, la pressione massima normale è 110-140 mmHg. Art., minimo – 60-80 mm. rt. Arte. L'attività muscolare aiuta ad aumentare la pressione massima a 200 mm Hg. Art., e la pressione minima praticamente non cambia o aumenta leggermente. Nelle persone allenate, dopo l'attività fisica, la pressione sanguigna si normalizza.
Precedente12345678910111213141516Avanti
Muscoli e loro funzioni
La contrazione muscolare fornisce il movimento del corpo e lo mantiene in posizione eretta. Insieme allo scheletro, i muscoli danno forma al corpo. La funzione dei singoli organi è associata all'attività dei muscoli: respirazione, digestione, circolazione sanguigna; i muscoli della laringe e della lingua sono coinvolti nella riproduzione del linguaggio articolato.
Nel corpo umano esistono tre tipi di tessuto muscolare: scheletrico, cardiaco e pareti degli organi interni. A seconda della struttura dei muscoli, questi si dividono in lisci (involontari) e striati (volontari).
La contrazione del tessuto striato è soggetta alla coscienza. Nel corpo umano ci sono circa 600 muscoli scheletrici, che rappresentano i 2/5 del peso corporeo totale.
Il muscolo scheletrico è ricoperto da una densa guaina di tessuto connettivo che è strettamente collegata al tessuto muscolare e ne impedisce lo stiramento eccessivo. Tra i fasci di fibre del muscolo ci sono vasi sanguigni e nervi. Alle estremità, il muscolo passa nel tendine, che ha una grande forza, ma a differenza dei muscoli, non si contrae.
Struttura muscolare
Un tipo speciale di tessuto muscolare è il muscolo cardiaco, formato da fibre muscolari striate, ma si contrae involontariamente. Di conseguenza, le caratteristiche funzionali e la struttura distinguono il muscolo cardiaco dagli altri muscoli.
Sono presenti muscoli corti e spessi, localizzati principalmente negli strati profondi vicino alla colonna vertebrale; lungo e sottile, situato sugli arti; largo e piatto, concentrato principalmente sul busto.
In base alla loro funzione i muscoli si dividono in flessori, estensori, adduttori, abduttori e rotatori. Quando i muscoli flessori si contraggono, gli estensori si rilassano contemporaneamente, garantendo la coordinazione dei movimenti.
I muscoli la cui contrazione provoca l’allontanamento dell’arto dal corpo sono detti abduttori, mentre i muscoli che avvicinano l’arto al corpo sono detti adduttori. Quando si contraggono, i muscoli rotatori ruotano l'una o l'altra parte del corpo (testa, spalla, avambraccio).
Nel corpo umano ci sono i muscoli del tronco, della testa, degli arti superiori e inferiori. I muscoli del tronco si dividono in muscoli del torace, della schiena e dell'addome. I muscoli del torace comprendono i muscoli intercostali esterni ed interni e il diaframma, o la barriera addominale, con l'aiuto della quale viene effettuata la respirazione. I muscoli pettorale maggiore e minore, il dentato anteriore e i muscoli succlavio muovono il cingolo scapolare e le braccia.
I muscoli addominali fanno sì che la colonna vertebrale si pieghi in avanti, di lato e la ruoti attorno all'asse longitudinale. Formano la stampa addominale, la cui contrazione favorisce l'espirazione profonda, l'escrezione di feci, urina e il travaglio nelle donne.
I muscoli superficiali della schiena (trapezio e latissimus) forniscono forza e movimento al cingolo scapolare e alle braccia. I muscoli profondi della schiena fissano la colonna vertebrale, ne provocano l'estensione, la flessione, la flessione laterale e la rotazione, l'estensione e la rotazione della testa e partecipano ai movimenti respiratori. Il muscolo più grande del collo è lo sternocleidomastoideo.
I muscoli della testa si dividono in due gruppi: masticatori e muscoli facciali. Il muscolo masticatorio stesso parte dal bordo inferiore dell'osso zigomatico ed è attaccato alla mascella inferiore. Contraendosi, solleva la mascella inferiore, partecipando alla masticazione del cibo.
I muscoli facciali sono attaccati da un lato alle ossa del cranio e dall'altro alla pelle del viso. Grazie a loro, il volto di una persona esprime determinate emozioni: rabbia, dolore, gioia. Inoltre, partecipano all'atto della parola e della respirazione.
I muscoli frontali si trovano sulla fronte e il muscolo orbicolare si trova attorno all'orbita (favorisce la chiusura delle palpebre). Intorno all'apertura orale si trova il muscolo orbicolare dell'oris.
I muscoli degli arti superiori sono divisi nei muscoli del cingolo scapolare (deltoide, pettorale maggiore e minore), che ne garantiscono la mobilità, e nei muscoli dell'arto libero. I muscoli più importanti dell'arto libero sono il muscolo bicipite (flette l'avambraccio) e il muscolo tricipite (nella parte posteriore dell'omero), che estende la spalla e l'avambraccio. Sulla superficie anteriore dell'avambraccio ci sono i muscoli - flessori dell'avambraccio, della mano e delle dita, sulla schiena - muscoli - estensori dell'avambraccio, della mano e delle dita.
I muscoli degli arti inferiori sono divisi nei muscoli della cintura pelvica e dell'arto libero. I muscoli pelvici comprendono il muscolo ileopsoas e i tre muscoli glutei, il più grande, che estende l'anca, è il grande gluteo. Sulla superficie posteriore della coscia si distinguono i muscoli semitendinoso, semimembranoso e bicipite, quando contratta la tibia si flette all'altezza dell'articolazione del ginocchio e la coscia si estende. Sulla superficie anteriore della coscia si trova il muscolo quadricipite che, quando contratto, estende la parte inferiore della gamba. Sulla superficie anteriore della parte inferiore della gamba ci sono i muscoli - estensori del piede e delle dita, sulla parte posteriore - i loro flessori. I più importanti sono il gastrocnemio e la suola. Entrambi i muscoli terminano nel tendine di Achille, che si attacca al tubercolo del tallone. Il muscolo gastrocnemio solleva il tallone durante la deambulazione e contribuisce a mantenere il corpo in posizione eretta.
I muscoli dell'arto superiore eseguono vari e numerosi movimenti del braccio. Poiché gli arti inferiori di una persona sostengono l'intero peso del corpo e assumono completamente la funzione del suo movimento, i loro muscoli sono molto più massicci e, quindi, più forti dei muscoli delle braccia, ma allo stesso tempo hanno una forza maggiore gamma limitata di movimenti.
Lavoro muscolare.
I movimenti delle articolazioni - flessione ed estensione degli arti - si realizzano grazie alla contrazione e al rilassamento alternati dei muscoli flessori ed estensori, che agiscono di concerto per l'innervazione dei loro centri nervosi, passando successivamente da uno stato di eccitazione a uno stato di inibizione.
Il lavoro muscolare è associato al consumo di energia, che è fornita dall'acido adenosina trifosforico (ATP), le sue riserve nei muscoli sono piccole e si esauriscono in una frazione di secondo. L'ATP viene sintetizzato grazie all'energia rilasciata durante l'ossidazione del glucosio, che viene portato ai muscoli dal sangue insieme ai nutrienti e porta via i prodotti di decadimento e l'anidride carbonica. Pertanto, l’efficienza della funzione muscolare dipende dall’apporto di sangue ai muscoli e, quindi, dal funzionamento del sistema cardiovascolare.
Si distingue tra lavoro statico e lavoro dinamico. Durante il lavoro statico, i muscoli sono in costante tensione, ma non si contraggono (sollevamento pesi, mantenimento di un carico). Questo tipo di lavoro è molto faticoso, soprattutto per i bambini e gli adolescenti.
Il lavoro muscolare dinamico è accompagnato da un'alternanza di contrazioni muscolari e rilassamenti (corsa, camminata, nuoto, giochi vari), è meno faticoso e richiede molta energia.
Un indicatore dell'efficienza del lavoro muscolare è il fattore di efficienza - efficienza, misurato con la formula (conosciuta dalla fisica) efficienza = A/Q.
Sistema muscolare e sue funzioni
cioè il rapporto tra il lavoro svolto e la quantità totale di energia spesa. L'efficienza dei muscoli umani è in media del 25-30%, ovvero il 30% di tutta l'energia viene spesa per la contrazione muscolare, il restante 70% viene convertito in calore.
L'affaticamento è un calo temporaneo delle prestazioni che si verifica a seguito del lavoro e scompare dopo il riposo. Per combattere la stanchezza è necessario alternare diverse attività.
Sistema muscolare(muscoli) è un sistema di organi di animali superiori e umani, formato da muscoli scheletrici, che, contraendosi, muovono le ossa dello scheletro, grazie ai quali il corpo esegue il movimento in tutte le sue manifestazioni.
Il sistema muscolare è assente negli organismi unicellulari e nelle spugne, tuttavia questi animali non sono privi della capacità di muoversi.
Il sistema muscolare è un insieme di fibre muscolari contrattili, riunite in fasci, che formano organi speciali - muscoli o fanno parte indipendentemente degli organi interni. La massa dei muscoli è molto maggiore della massa degli altri organi: nei vertebrati può raggiungere fino al 50% della massa corporea totale, in un adulto fino al 40%. Il tessuto muscolare animale è anche chiamato carne e, insieme ad altri componenti del corpo animale, viene utilizzato come cibo. Nel tessuto muscolare, l'energia chimica viene convertita in energia meccanica e calore.
Nei vertebrati i muscoli si dividono in due gruppi principali:
- Somatico(cioè racchiuso nelle pareti delle cavità del corpo ("soma"), racchiudendo le parti interne e formando anche la maggior parte degli arti):
- Muscoli scheletrici(sono anche striati, o arbitrari). Attaccato alle ossa. Sono costituiti da fibre molto lunghe, lunghezza da 1 a 10 cm, forma cilindrica. Le loro striature trasversali sono dovute alla presenza di dischi alternati birifrangenti attraverso la luce trasmessa - anisotropi, più scuri, e monorifrangenti - isotropi, più chiari. Ciascuna fibra muscolare è costituita da citoplasma indifferenziato, o sarcoplasma, con numerosi nuclei situati lungo la periferia, che contiene un gran numero di miofibrille striate differenziate. La periferia della fibra muscolare è circondata da una membrana trasparente, o sarcolemma, contenente fibrille di collagene. Piccoli gruppi di fibre muscolari sono circondati da una membrana di tessuto connettivo: endomisio, endomisio; i complessi più grandi sono rappresentati da fasci di fibre muscolari, che sono racchiusi in tessuto connettivo lasso - perimisio interno, perimisio internum; l'intero muscolo nel suo insieme è circondato dal perimisio esterno, perimisio esterno. Tutte le strutture del tessuto connettivo del muscolo, dal sarcolemma al perimisio esterno, sono una continuazione l'una dell'altra e sono continuamente interconnesse. L'intero muscolo è coperto da una guaina di tessuto connettivo - fascia. Ogni muscolo è raggiunto da uno o più nervi e vasi sanguigni che lo riforniscono. Entrambi penetrano nello spessore del muscolo nella zona del cosiddetto campo neurovascolare, area nervovasculosa. Con l'aiuto dei muscoli, viene mantenuto l'equilibrio del corpo, viene eseguito il movimento nello spazio, vengono eseguiti movimenti di respirazione e deglutizione.
Sistema muscolare
Questi muscoli si contraggono con la forza della volontà sotto l'influenza degli impulsi trasmessi loro attraverso i nervi dal sistema nervoso centrale. Caratterizzato da contrazioni potenti e rapide e da un rapido sviluppo della fatica.
Nel corpo umano ci sono circa 400 muscoli striati, la cui contrazione è controllata dal sistema nervoso centrale.
Funzioni del sistema muscolare
- il motore;
- protettivo (ad esempio, proteggendo la cavità addominale con la pressa addominale);
- formativo (lo sviluppo muscolare determina in una certa misura la forma del corpo e la funzione di altri sistemi, ad esempio il sistema respiratorio);
- energia (conversione dell'energia chimica in meccanica e termica).
CC©wikiredia.ru
Cerca lezioni
Caratteristiche generali del sistema muscolare
Muscoli scheletrici
Funzioni dei muscoli scheletrici:
2. Mantenere la postura.
5. Influisce sulla forma e sullo sviluppo delle ossa.
Classificazione dei muscoli scheletrici
Secondo la struttura del corpo, secondo il principio della simmetria bilaterale, i muscoli sono accoppiati o sono costituiti da due metà simmetriche.
Nel corpo umano ci sono circa 400 muscoli. Hanno forme, dimensioni, posizioni e funzioni diverse. La classificazione dei muscoli è possibile secondo diversi principi.
Per forma si distinguono i muscoli: lunghi (situati principalmente sugli arti), corti e larghi (situati principalmente sul busto)
Per posizione i muscoli si dividono in: superficiali e profondi; muscoli del tronco, muscoli della testa, muscoli del collo; muscoli degli arti.
Per funzione I muscoli sono: flessori, estensori, adduttori - abduttori, rotatori, chiusure (sfinteri) - dilatatori, elevatori - depressori, sinergici - antagonisti.
Un gruppo speciale di muscoli scheletrici sono i muscoli facciali. Non hanno un doppio attacco alle ossa, ma sono sempre attaccati alla pelle ad un'estremità. Il lavoro dei muscoli facciali determina le espressioni facciali ed è coinvolto nella masticazione e nella parola.
Struttura muscolare
Ogni muscolo è un organo separato, ad es. una formazione olistica che ha una sua forma, struttura, funzione, sviluppo, posizione specifica nel corpo ed è composta da diversi tessuti.
Ogni muscolo è costituito da fasci di fibre muscolari striate (cioè cellule muscolari) che corrono parallele tra loro. Un certo numero di tali fibre sono unite da tessuto connettivo lasso in fasci muscolari del primo ordine. Molti di questi fasci sono combinati in fasci muscolari del secondo ordine, ecc. Nelle membrane del tessuto connettivo dei fasci muscolari ci sono capillari sanguigni che forniscono i nervi muscolari, motori e sensoriali. In generale, i fasci muscolari di tutti gli ordini sono uniti da una comune membrana di tessuto connettivo, che costituisce il ventre muscolare. Il tessuto connettivo che delimita i fasci muscolari forma i tendini alle estremità del ventre muscolare. I singoli muscoli e gruppi muscolari sono circondati da membrane di tessuto connettivo dense e resistenti chiamate fascia, che facilita lo scorrimento durante la contrazione muscolare e svolge una funzione protettiva.
Ogni muscolo è abbondantemente rifornito di vasi sanguigni, linfatici e nervi, il che garantisce il normale metabolismo delle cellule muscolari.
Funzionalmente, ogni muscolo ha una parte attiva che può contrarsi - l'addome, e una parte passiva - i tendini, attraverso i quali il muscolo è attaccato alle ossa.
Tessuto muscolare scheletrico a strisce incrociate, la cui proprietà è la contrattilità e determina le proprietà dei muscoli come organo di contrazione.
Lavoro muscolare
Le principali proprietà del tessuto muscolare sono l'eccitabilità, la conduttività e la contrattilità. Il lavoro dei muscoli si basa su queste proprietà.
Per effetto della contrazione il ventre muscolare si accorcia e i due punti di inserzione muscolare si avvicinano (il punto mobile si avvicina a quello stazionario). Di conseguenza, il movimento avviene in questa parte del corpo.
Di norma, più muscoli sono coinvolti contemporaneamente nell'esecuzione di un movimento. I muscoli che eseguono simultaneamente movimenti in una direzione sono chiamati sinergici (ad esempio, flessori della spalla).
Sistema muscolare umano. La struttura del sistema muscolare umano
I muscoli che eseguono movimenti in direzioni opposte sono chiamati antagonisti (ad esempio, i muscoli flessori-estensori della spalla).
I muscoli lavorano di riflesso, cioè contrarre sotto l'influenza degli impulsi nervosi provenienti dal sistema nervoso centrale lungo gli assoni dei motoneuroni verso ciascuna cellula muscolare. Sotto l'influenza di un impulso nervoso ricevuto da una cellula muscolare, nella sua membrana si forma un potenziale d'azione e vengono rilasciati ioni calcio. Gli ioni di calcio innescano l'intero meccanismo di contrazione delle cellule muscolari. Il muscolo risponde ad ogni singolo impulso nervoso con una contrazione. La natura della contrazione muscolare dipende dalla frequenza degli impulsi nervosi in arrivo e dalla durata del loro arrivo.
In condizioni naturali, un muscolo contratto si trova in uno stato di tetano (forte contrazione prolungata) con una frequenza di impulsi nervosi di 40-50 al secondo. Il tetano si verifica a causa della somma delle contrazioni muscolari individuali. Ad una frequenza di 10-20 impulsi/sec il muscolo è in uno stato di tono, cioè una certa contrazione, necessaria per mantenere la postura ed eseguire i movimenti.
©2015-2018 poisk-ru.ru
Cerca lezioni
Il concetto di sistema motorio. Tipi e funzioni delle unità motorie (MU). Composizione muscolare
Il movimento è una condizione necessaria per lo sviluppo e l'esistenza di un organismo, il suo adattamento all'ambiente. È il movimento la base del comportamento intenzionale, che si rivela nelle parole di N.A. Bernstein: “L'ovvio enorme significato biologico dell'attività motoria degli organismi è quasi l'unica forma di attuazione non solo dell'interazione con l'ambiente, ma anche un'influenza attiva su questo ambiente, modificandolo in modi non indifferenti ai risultati individuali..." Un'altra manifestazione dell'importanza dei movimenti è che la base di qualsiasi attività professionale è il lavoro dei muscoli.
Tutte le varietà di attività motorie vengono svolte con l'aiuto di sistema muscoloscheletrico. È costituito da formazioni anatomiche specializzate: muscoli, scheletro e sistema nervoso centrale.
Nel sistema muscolo-scheletrico, con un certo grado di convenzione, si distingue una parte passiva - lo scheletro e una parte attiva - i muscoli.
Lo scheletro comprende le ossa e le loro articolazioni(ad esempio articolazioni).
Scheletro funge da supporto per gli organi interni, luogo di attacco muscolare e protegge gli organi interni da danni meccanici esterni. Le ossa dello scheletro contengono midollo osseo, un organo emopoietico. Le ossa contengono un gran numero di minerali (i più rappresentati sono calcio, sodio, magnesio, fosforo e cloro). L'osso è un tessuto vivente dinamico con elevata sensibilità a vari meccanismi regolatori e influenze endogene ed esogene. L'osso non è solo un organo di supporto, ma anche il partecipante più importante nel metabolismo minerale (per maggiori dettagli vedere la sezione Metabolismo). Un indicatore integrale dell'attività metabolica del tessuto osseo sono i processi di ristrutturazione attiva e rinnovamento delle strutture ossee che continuano per tutta la vita. Questi processi, da un lato, sono un meccanismo importante per il mantenimento dell'omeostasi minerale, dall'altro garantiscono l'adattamento strutturale dell'osso alle mutevoli condizioni operative, che è particolarmente importante in connessione con l'educazione fisica e lo sport regolari. La base dei processi costantemente in corso di rimodellamento osseo è l'attività delle cellule ossee: osteoblasti e osteoclasti.
Muscoli Grazie alla capacità di contrarsi, muovono le singole parti del corpo e garantiscono anche il mantenimento di una determinata postura. La contrazione muscolare è accompagnata dalla produzione di una grande quantità di calore, il che significa che i muscoli che lavorano sono coinvolti nella generazione di calore. I muscoli ben sviluppati sono un'ottima protezione per gli organi interni, i vasi sanguigni e i nervi.
Ossa e muscoli, sia in termini di massa che di volume, costituiscono una parte significativa dell'intero corpo; esistono significative differenze di genere nel loro rapporto; La massa muscolare di un uomo adulto va dal 35 al 50% (a seconda di quanto sono sviluppati i muscoli) del peso corporeo totale, per le donne è di circa il 32-36%. Per gli atleti specializzati negli sport di forza, la massa muscolare può raggiungere il 50-55% e per i bodybuilder il 60-70% del peso corporeo totale. Le ossa rappresentano il 18% del peso corporeo negli uomini e il 16% nelle donne.
Negli esseri umani esistono tre tipi di muscoli:
muscoli scheletrici striati;
muscolo cardiaco striato;
muscolo liscio organi interni, pelle, vasi sanguigni.
Muscolo liscio sono divisi in Tonico(non in grado di sviluppare contrazioni “veloci” negli sfinteri degli organi cavi) e fase-tonico(che si dividono in quelli con automatico, cioè. la capacità di generare spontaneamente contrazioni fasiche. Un esempio potrebbero essere i muscoli del tratto gastrointestinale e degli ureteri e non avere questa proprietà– lo strato muscolare delle arterie, dei dotti seminali, del muscolo dell'iride, si contraggono sotto l'influenza degli impulsi del sistema nervoso autonomo. L'innervazione motoria della muscolatura liscia viene effettuata da processi di cellule del sistema nervoso autonomo, sensibile - da processi di cellule dei gangli spinali. Di regola, la contrazione della muscolatura liscia non può essere provocata volontariamente; la corteccia cerebrale non partecipa alla regolazione delle sue contrazioni. La funzione dei muscoli lisci è quella di mantenere la tensione a lungo termine, mentre consumano da 5 a 10 volte meno ATP di quanto i muscoli scheletrici avrebbero bisogno per svolgere lo stesso compito.
I muscoli lisci forniscono la funzione degli organi cavi, le pareti di cui formano. Grazie alla muscolatura liscia, viene eseguito espulsione dei contenuti dalla vescica, dall'intestino, dallo stomaco, dalla cistifellea, dall'utero. I muscoli lisci forniscono funzione dello sfintere– creare le condizioni per immagazzinare determinati contenuti in un organo cavo (urina nella vescica, feto nell’utero). Modificando il lume dei vasi sanguigni, i muscoli lisci adattano il flusso sanguigno regionale ai bisogni locali di ossigeno e sostanze nutritive e partecipano alla regolazione della respirazione modificando il lume dell'albero bronchiale.
Muscoli scheletrici sono una parte attiva del sistema muscolo-scheletrico, fornendo attività mirate, principalmente attraverso movimenti volontari (le caratteristiche della loro struttura e i principi di funzionamento sono discussi più dettagliatamente di seguito).
Tipi di fibre muscolari
I muscoli sono costituiti da fibre muscolari che variano in forza, velocità, durata della contrazione e affaticamento. Gli enzimi in essi contenuti hanno attività diverse e sono presentati in diverse forme isomeriche. C'è una notevole differenza nel contenuto degli enzimi respiratori: glicolitici e ossidativi.
Sistema muscolare e sue funzioni
In base al rapporto tra miofibrille, mitocondri e mioglobina, il cosiddetto bianco rosso E fibre intermedie . In base alle loro caratteristiche funzionali, le fibre muscolari sono suddivise in veloce lento E intermedio . Se le fibre muscolari differiscono abbastanza nettamente nell'attività dell'ATPasi, il grado di attività degli enzimi respiratori varia in modo abbastanza significativo, quindi, insieme al bianco e al rosso, ci sono anche fibre intermedie.
Le fibre muscolari differiscono più chiaramente nell'organizzazione molecolare della miosina. Tra le sue varie isoforme, ce ne sono due principali: "veloce" e "lenta". Quando si eseguono reazioni istochimiche, si distinguono per l'attività dell'ATPasi. Anche l'attività degli enzimi respiratori è correlata a queste proprietà. Di solito dentro fibre veloci(Fibre FF - contrazione veloce, fibre a contrazione rapida), predominano i processi glicolitici, sono più ricche di glicogeno, hanno meno mioglobina, per questo vengono chiamate anche bianche. IN fibre lente, denominate fibre S (ST) (fibre a contrazione lenta), invece, hanno una maggiore attività degli enzimi ossidativi, sono più ricche di mioglobina e si presentano più rosse. Si accendono con carichi compresi tra il 20 e il 25% della forza massima e hanno una buona resistenza.
 Le fibre FT, che hanno un basso contenuto di mioglobina rispetto alle fibre rosse, sono caratterizzate da un'elevata velocità contrattile e dalla capacità di sviluppare maggiore forza. Rispetto alle fibre a contrazione lenta, possono contrarsi due volte più velocemente e produrre una forza 10 volte maggiore. Le fibre FT, a loro volta, si dividono in fibre FTO e FTG. Differenze significative tra i tipi elencati di fibre muscolari sono determinate dal metodo per ottenere energia (Fig. 2.1).
Le fibre FT, che hanno un basso contenuto di mioglobina rispetto alle fibre rosse, sono caratterizzate da un'elevata velocità contrattile e dalla capacità di sviluppare maggiore forza. Rispetto alle fibre a contrazione lenta, possono contrarsi due volte più velocemente e produrre una forza 10 volte maggiore. Le fibre FT, a loro volta, si dividono in fibre FTO e FTG. Differenze significative tra i tipi elencati di fibre muscolari sono determinate dal metodo per ottenere energia (Fig. 2.1).
Riso. 2.1 Differenze nell'apporto energetico tra i diversi tipi di fibre muscolari(da http://medi.ru/doc/g740203.htm).
La produzione di energia nelle fibre FTO avviene allo stesso modo delle fibre ST, principalmente attraverso la fosforilazione ossidativa. Poiché questo processo di degradazione è relativamente economico (39 composti fosfatici energetici vengono immagazzinati per ogni molecola di glucosio quando il glicogeno muscolare viene scomposto per produrre energia), le fibre FTO hanno anche una resistenza alla fatica relativamente elevata. L'accumulo di energia nelle fibre FTG avviene principalmente attraverso la glicolisi, ovvero il glucosio in assenza di ossigeno si scompone in lattato, che è ancora relativamente ricco di energia. A causa del fatto che questo processo di decomposizione è antieconomico (per ogni molecola di glucosio vengono accumulati solo 3 composti fosfatici energetici per produrre energia), le fibre FTG si affaticano in tempi relativamente brevi, ma sono comunque in grado di sviluppare una grande forza e, di regola, accendersi con contrazioni muscolari submassimali e massime.
Unità motorie
Il principale elemento morfofunzionale dell'apparato neuromuscolare dei muscoli scheletrici è unità motoria–DE(Fig. 2.2.).

Figura 2.2. Unità motore
L'unità motoria comprende un motoneurone del midollo spinale con fibre muscolari innervate dal suo assone. All'interno del muscolo, questo assone forma diversi rami terminali. Ciascuno di questi rami forma un contatto: una sinapsi neuromuscolare su una fibra muscolare separata. Gli impulsi nervosi provenienti da un motoneurone causano le contrazioni di un gruppo specifico di fibre muscolari. Le MU dei piccoli muscoli che eseguono movimenti fini (muscoli dell'occhio, delle mani) contengono un piccolo numero di fibre muscolari. Nei muscoli grandi ce ne sono centinaia di volte di più.
Le MU vengono attivate secondo la legge “tutto o niente”. Pertanto, se un impulso viene inviato dal corpo del motoneurone del corno anteriore del midollo spinale lungo le vie nervose, tutte le fibre muscolari della MU reagiscono ad esso. oppure nessuno. Per i bicipiti ciò significa quanto segue: con un impulso nervoso Con la forza necessaria vengono accorciati tutti gli elementi contrattili (miofibrille) di tutte (circa 1500) fibre muscolari dell'unità motoria corrispondente.
Tutte le MU, a seconda delle loro caratteristiche funzionali, sono divise in 3 gruppi:
IO. Lento e instancabile. Sono formati da fibre muscolari “rosse”, che hanno meno miofibrille. La velocità di contrazione e la forza di queste fibre sono relativamente piccole, ma sono poco affaticate, quindi queste fibre sono classificate come toniche. La regolazione delle contrazioni di tali fibre viene effettuata da un piccolo numero di motoneuroni, i cui assoni hanno pochi rami terminali. Un esempio è il muscolo soleo.
IIV. Veloce, facilmente stanco. Le fibre muscolari contengono molte miofibrille e sono chiamate "bianche". Si contraggono rapidamente e sviluppano una grande forza, ma si stancano rapidamente. Ecco perché vengono chiamati fase. I motoneuroni di queste unità motorie sono i più grandi e hanno un assone spesso con numerosi rami terminali. Generano impulsi nervosi ad alta frequenza. Ad esempio, i muscoli dell'occhio.
IIA. Veloce, resistente alla fatica(intermedio).
Tutte le fibre muscolari di una MU appartengono allo stesso tipo di fibre (fibre FT o ST).
I muscoli coinvolti nell'esecuzione di movimenti molto precisi e differenziati (ad esempio i muscoli degli occhi o delle dita) sono solitamente costituiti da un gran numero di UM (da 1500 a 3000). Tali MU hanno un numero limitato di fibre muscolari (da 8 a 50). I muscoli che eseguono movimenti relativamente meno precisi (ad esempio i grandi muscoli degli arti) hanno un numero di unità motorie significativamente inferiore, ma la loro composizione comprende un gran numero di fibre (da 600 a 2000).
La persona media ha circa il 40% di fibre lente e il 60% di fibre veloci. Ma questo è un valore medio (tra tutti i muscoli scheletrici), i muscoli svolgono funzioni diverse. La composizione quantitativa e qualitativa dei muscoli è eterogenea; comprendono un numero diverso di unità motorie, anche il rapporto tra i tipi è diverso ( composizione muscolare). A questo proposito, le capacità contrattili dei diversi muscoli non sono le stesse. I muscoli esterni dell'occhio, che ruotano il bulbo oculare, sviluppano la massima tensione in una contrazione della durata di soli 7,5 ms; il soleo, muscolo antigravità dell'arto inferiore, sviluppa molto lentamente la massima tensione entro 100 ms; I muscoli che eseguono molto lavoro statico (soleo) hanno spesso un gran numero di fibre ST lente, mentre i muscoli che eseguono principalmente movimenti dinamici (bicipiti) hanno spesso un gran numero di fibre FT.
Le principali proprietà delle fibre muscolari (e quindi delle unità motorie in esse contenute), determinate anche dalle proprietà dei motoneuroni, sono presentate nella Tabella 1.
Tabella 2.1
©2015-2018 poisk-ru.ru
Tutti i diritti appartengono ai loro autori. Questo sito non ne rivendica la paternità, ma ne fornisce l'uso gratuito.
Violazione del copyright e violazione dei dati personali
Il movimento è fornito dal lavoro dei muscoli, che possono essere formati da tessuto muscolare striato scheletrico, liscio e cardiaco. Il tessuto muscolare liscio forma i muscoli degli organi interni, il tessuto cardiaco forma il muscolo del cuore. Il tessuto muscolare scheletrico a strisce incrociate forma i muscoli scheletrici e alcuni organi interni, ad esempio la lingua, il terzo superiore della parete dell'esofago, ecc.).
Muscoli scheletrici fanno parte dell'apparato motorio, ne costituiscono la parte attiva. I muscoli scheletrici dell'uomo, rispetto agli animali, hanno subito profondi cambiamenti in relazione alla deambulazione eretta, alla capacità di lavorare e all'articolazione della parola.
La massa muscolare scheletrica di un uomo adulto è in media del 42%, nelle donne - 36% del peso corporeo e conta circa 400 muscoli.
Funzioni dei muscoli scheletrici:
1. Fornire movimento al corpo nel suo insieme e alle sue singole parti l'una rispetto all'altra.
2. Mantenere la postura.
3. Promuovere la circolazione sanguigna e linfatica.
4. Fornire movimenti specifici: movimenti respiratori, masticazione, deglutizione, espressioni facciali, articolazione dei suoni.
Sistema muscolare del corpo umano: struttura e funzioni
Influenzano la forma e lo sviluppo delle ossa.
6. Convertono l'energia chimica in energia termica, essendo organi di produzione di calore nel corpo.
7. Accumulano una sostanza energetica di riserva: il glicogeno dell'amido animale.
Data di pubblicazione: 30-12-2014; Leggi: 199 | Violazione del copyright della pagina
studopedia.org - Studopedia.Org - 2014-2018 (0,001 s)…
Nel corpo umano ci sono circa 300-330 muscoli striati accoppiati, che insieme allo scheletro formano il sistema muscolo-scheletrico. Il muscolo scheletrico è costituito da numerose fibre muscolari disposte parallelamente tra loro. Queste fibre multinucleate raggiungono talvolta diversi centimetri di lunghezza. Ciascuna fibra muscolare contiene un gran numero di miofibrille disposte in modo ordinato formate da proteine specifiche, le principali delle quali sono actina e miosina. Le fibre muscolari sono unite in fasci circondati da tessuto connettivo. Molti di questi fasci, a loro volta, sono circondati come una custodia da tessuto connettivo fibroso. Le membrane del tessuto connettivo del muscolo sono penetrate dai vasi sanguigni e fornite di nervi. Un muscolo è diviso in parti muscolari e tendinee; la parte centrale ispessita e che si contrae attivamente è chiamata addome (corpo) e le due estremità sono chiamate testa e coda. A seconda del numero di capi, il muscolo viene classificato come bicipite, tricipite e quadricipite. Molti muscoli hanno tendini ad entrambe le estremità attraverso i quali sono attaccati alle ossa. I tendini sono formati da tessuto connettivo fibroso denso e sono in grado di sopportare carichi di trazione pesanti; attaccandosi alle ossa, crescono strettamente insieme al periostio. Variano in larghezza e lunghezza tra i diversi muscoli e possono assumere la forma di una corda, un nastro o una struttura larga e piatta (ad esempio, nei muscoli che formano la parete addominale) chiamata distorsione del tendine o aponeurosi. I muscoli contengono anche vasi sanguigni e nervi.
I muscoli muscolari nei vertebrati sono divisi in due gruppi principali:
Somatico (cioè racchiuso nelle pareti delle cavità del corpo ("soma"), racchiudendo le parti interne e formando anche la maggior parte degli arti). Ciò include i muscoli scheletrici.
Viscerale(cioè parte degli interni, funzionalmente non adatta al movimento del corpo nello spazio). Questi sono muscoli cardiaci e lisci.
Immagine: “Biologia. Una moderna enciclopedia illustrata." cap. ed. AP Gorkin; M.: Rosmann, 2006.
Anche l'azione motoria più semplice coinvolge diversi gruppi muscolari. Allo stesso tempo, alcuni muscoli si contraggono più energicamente e svolgono il lavoro principale, altri sono meno attivi, ma senza la loro partecipazione l'esecuzione di una specifica azione motoria sarebbe impossibile. Ad esempio, quando si flette ed estende il braccio nell'articolazione del gomito, i muscoli bicipiti, tricipiti e brachiali lavorano con intensità variabile. Quando si piega il corpo lateralmente, il lavoro principale viene eseguito dal muscolo addominale obliquo esterno, ma nel movimento è coinvolto anche il muscolo retto dell'addome. I muscoli, contraendosi in diverse sequenze e combinazioni, muovono le singole parti del corpo. Con la frequente ripetizione degli stessi movimenti, i movimenti diventano più forti, più veloci e più precisi, il che è associato al miglioramento delle caratteristiche qualitative dei muscoli e del loro sviluppo.
In condizioni naturali, isolato dagli altri, un muscolo si contrae molto raramente; di solito anche i muscoli vicini sono coinvolti nel lavoro di forza, il loro numero può raggiungere diverse dozzine; Solo modificando la posizione del corpo, la struttura dei movimenti e utilizzando tecniche speciali si possono creare le condizioni per l'inclusione di un numero limitato di muscoli nel lavoro e quindi creare le condizioni per il loro sviluppo preferenziale, in base agli scopi e agli obiettivi del periodo di addestramento. Ma per questo è necessario avere una conoscenza abbastanza buona dei principali gruppi muscolari, della loro posizione e funzioni.
Tipicamente un muscolo si attacca a due ossa diverse. La sua funzione si riduce al fatto che quando si contrae, attrae le ossa tra loro o le mantiene in una determinata posizione. Durante la contrazione, un'estremità del muscolo rimane immobile (punto fisso) e la seconda, attaccata a un altro osso, cambia posizione (punto mobile). Quando si eseguono vari movimenti, i punti fissi e mobili possono cambiare posizione. Le ossa collegate dalle articolazioni agiscono come leve meccaniche quando i muscoli si contraggono. Negli animali (ad esempio i cavalli), parte dei muscoli è attaccata alla pelle e forma un ampio strato sottocutaneo, che svolge un ruolo importante nella protezione dalle punture di insetti. Negli esseri umani, i muscoli di questo tipo sono conservati solo sulla testa e sul collo, sono particolarmente ben sviluppati intorno agli occhi e alla bocca; questo è il cosiddetto muscoli facciali o facciali, con l'aiuto dei quali viene espresso lo stato emotivo di una persona. La forza muscolare sviluppata durante la contrazione o la tensione dipende da fattori anatomici, meccanici, fisiologici e di altro tipo.
I nomi sono stati assegnati ai muscoli per secoli. Nella maggior parte dei casi si tratta di termini descrittivi che riflettono la dimensione, la posizione, la forma, la struttura, l'inserzione o la funzione di un muscolo. Sono ancora in uso oggi, come il romboide maggiore (forma e dimensione), il pronatore quadrato (forma e funzione), l'elevatore della scapola (funzione e inserzione).
La dimensione dei muscoli varia dal muscolo gluteo massimo, che estende l'anca, ad esempio quando si salgono le scale, al piccolissimo muscolo stapedio (lungo 3 mm), che regola la sensibilità dell'orecchio alle vibrazioni sonore.
Funzioni
Il motore . Questa è una delle funzioni principali dei muscoli scheletrici. I muscoli sono in grado di sviluppare forza solo quando sono accorciati (cioè possono solo tirare, non spingere); quindi, per rimuovere un osso e poi riportarlo nella sua posizione originale, sono necessari almeno due muscoli o due gruppi di muscoli. Le coppie di muscoli che agiscono in questo modo sono chiamate antagonisti. La classificazione dei muscoli in base ai tipi di movimenti prodotti dalle coppie di muscoli antagonisti è ampia; Concentriamoci su una delle coppie principali. I flessori flettono l'arto tirando l'uno verso l'altro due elementi scheletrici; gli estensori raddrizzano l'arto. Consideriamo il movimento più semplice: piegare il braccio all'altezza del gomito. Coinvolge due gruppi di muscoli della spalla: gli anteriori (flessori) e i posteriori (estensori). Il gruppo anteriore dei muscoli è costituito dai muscoli bicipite brachiale (bicipite) e brachiale, mentre il gruppo posteriore è costituito dal muscolo tricipite (tricipite) e dall'olecrano minore. Il gruppo anteriore, passando sopra l'articolazione del gomito, si contrae quando il braccio è piegato, mentre il gruppo posteriore, passando dietro l'articolazione, si rilassa. Quando distendi il braccio, i tricipiti si accorciano e i bicipiti si rilassano gradualmente, garantendo così un movimento fluido.
Molto raramente, nel movimento è coinvolta solo una coppia di muscoli antagonisti. Tipicamente, ogni movimento individuale è guidato da gruppi muscolari; i muscoli che agiscono insieme e unidirezionalmente (ad esempio un gruppo di flessori) sono chiamati sinergici.
Raccoglitore. Con alcuni muscoli, i movimenti che producono non sono così importanti quanto quelli che impediscono. Pertanto, un gruppo di quattro muscoli - piccolo rotondo, infraspinato, sovraspinato e sottoscapolare - circonda l'articolazione della spalla, mantenendo l'estremità superiore a forma di palla (testa) dell'omero nella cavità glenoidea poco profonda. I muscoli del piede sostengono l'arco plantare e sono un altro esempio di muscoli che mantengono l'allineamento delle ossa.
Funzione di supporto . La cavità addominale è formata principalmente da muscoli larghi e piatti che sostengono gli organi interni. Le pareti anteriore e laterale della cavità sono ricoperte da tre strati di muscoli, e il suo fondo è formato nell'uomo da due muscoli: l'elevatore dell'ano e il coccigeo (nei tetrapodi questi due muscoli assicurano il movimento della coda).
Sviluppo legato all'età del sistema muscolare
Il sistema muscolare umano viene valutato mediante una serie di parametri interdipendenti, caratterizzati da varie proprietà muscolari, indicatori di massa muscolare, forza muscolare e prestazione muscolare.
Nell'adolescenza, le proprietà fisico-chimiche dei muscoli continuano a cambiare notevolmente e le loro proprietà funzionali migliorano. La composizione chimica del tessuto muscolare è vicina a quella di un adulto. Segni di maturità morfologica si vedono nella struttura delle fibre muscolari e aumenta la massa del tessuto contrattile. Nei giovani i muscoli sono più elastici che negli adulti e hanno una maggiore contrattilità. La maturità morfologica e funzionale viene raggiunta innanzitutto dai muscoli, dalle cui funzioni dipende il risultato dell'attività sportiva. All'età di 16-17 anni, il diametro anatomico dei muscoli raggiunge i livelli di un adulto, ma la crescita muscolare in lunghezza continua fino a 23-25 anni.
L'adattamento del sistema muscolare all'attività fisica è associato, prima di tutto, all'ipertrofia delle fibre muscolari. Si osserva anche un aumento del loro numero: le fibre si dividono longitudinalmente o si staccano dalla fibra madre.
Lo sviluppo del corpo giovanile è strettamente correlato alla crescita della massa muscolare. Con l'età si verificano i suoi cambiamenti: a 7-8 anni la massa totale dei muscoli scheletrici aumenta al 28% e a 12 anni rappresenta fino al 29,4% del peso corporeo totale. All'età di 15 anni, la massa muscolare aumenta al 32,6%, dal 18 al 44,2%. All'età di 20 anni, la massa muscolare rappresenta fino al 40-45% del peso corporeo totale.
Si noti che i cambiamenti nella massa muscolare dopo 17 anni sono associati a influenze esterne (nutrizione, attività fisica), nonché a caratteristiche genetiche. L'aumento della massa muscolare a 16-17 anni è di 3,8 kg (16,1%); a 17-18 anni - 11,4 kg (5,6%); a 18-19 anni - 11,0 kg (4,1%); a 19-20 anni - 10,3 kg (1,2%).
Fare sport elimina in una certa misura possibili squilibri nell’aumento della massa muscolare. Allo stesso tempo, uno sforzo muscolare eccessivo porta ad una rapida ipertrofia delle fibre muscolari. Quindi, ad esempio, tra i sollevatori di pesi eccezionali, i muscoli possono costituire più del 50% del peso corporeo (con una norma del 35-40%) e per i giocatori di football - più del 30% (con una norma del 15-20%) .
All’aumentare della massa muscolare aumenta anche la forza muscolare. Secondo numerosi studi esistono differenze sia di età che di sesso nello sviluppo della forza dei singoli gruppi muscolari.
La forza mortale nei ragazzi dai 7 ai 12 anni aumenta dell'11%. A partire dall'adolescenza, si notano differenze significative negli indicatori di forza muscolare: a 12 anni la spina dorsale è in media di 52 kg, a 15 anni - 92 kg, a 18 anni - 125 kg.
Lo sviluppo della forza dei muscoli flessori, per la loro costante tensione tonica determinata dall'azione di gravità degli arti, precede lo sviluppo dei muscoli estensori. A questo proposito, nel processo di allenamento dei calciatori è necessario utilizzare esercizi mirati specificatamente al rafforzamento dei muscoli estensori.
Che, contraendosi, mette in movimento le ossa dello scheletro, grazie alle quali il corpo compie il movimento in tutte le sue manifestazioni.
Il sistema muscolare è assente negli organismi unicellulari e nelle spugne, tuttavia questi animali non sono privi della capacità di muoversi.
Il sistema muscolare è un insieme di fibre muscolari capaci di contrazione, riunite in fasci, che formano organi speciali - muscoli o fanno parte indipendentemente degli organi interni. La massa dei muscoli è molto maggiore della massa degli altri organi: negli animali vertebrati può raggiungere fino al 50% della massa corporea totale, in un adulto fino al 40%. Il tessuto muscolare animale è anche chiamato carne e, insieme ad altri componenti del corpo animale, viene utilizzato come cibo. Nel tessuto muscolare, l'energia chimica viene convertita in energia meccanica e calore.
Nei vertebrati i muscoli si dividono in due gruppi principali:
- Somatico(cioè racchiuso nelle pareti delle cavità del corpo ("soma"), racchiudendo le parti interne e formando anche la maggior parte degli arti):
- Muscoli scheletrici(sono anche striati, o arbitrari). Attaccato alle ossa. Sono costituiti da fibre molto lunghe, lunghezza da 1 a 10 cm, forma cilindrica. Le loro striature trasversali sono dovute alla presenza di dischi alternati che sono birifrangenti attraverso la luce trasmessa - anisotropa, più scura, e la luce uniriflettente - isotropa, più chiara. Ciascuna fibra muscolare è costituita da citoplasma indifferenziato, o sarcoplasma, con numerosi nuclei situati lungo la periferia, che contiene un gran numero di miofibrille striate differenziate. La periferia della fibra muscolare è circondata da una membrana trasparente, o sarcolemma, contenente fibrille di collagene. Piccoli gruppi di fibre muscolari sono circondati da una membrana di tessuto connettivo: endomisio, endomisio; i complessi più grandi sono rappresentati da fasci di fibre muscolari, che sono racchiusi in tessuto connettivo lasso - perimisio interno, perimisio internum; l'intero muscolo nel suo insieme è circondato dal perimisio esterno, perimisio esterno. Tutte le strutture del tessuto connettivo del muscolo, dal sarcolemma al perimisio esterno, sono una continuazione l'una dell'altra e sono continuamente interconnesse. L'intero muscolo è coperto da una guaina di tessuto connettivo - fascia. Ogni muscolo è raggiunto da uno o più nervi e vasi sanguigni che lo riforniscono. Entrambi penetrano nello spessore del muscolo nella zona del cosiddetto campo neurovascolare, area nervovasculosa. Con l'aiuto dei muscoli, viene mantenuto l'equilibrio del corpo, viene eseguito il movimento nello spazio, vengono eseguiti movimenti di respirazione e deglutizione. Questi muscoli si contraggono con la forza della volontà sotto l'influenza degli impulsi forniti loro attraverso i nervi del sistema nervoso centrale. Caratterizzato da contrazioni potenti e rapide e da un rapido sviluppo della fatica.
- Viscerale(cioè parte degli interni, funzionalmente non adatta al movimento del corpo nello spazio):
- Muscoli lisci(involontario). Si trovano nelle pareti degli organi interni e dei vasi sanguigni. Sono caratterizzati da lunghezza: 0,02 -0,2 mm, forma: fusiforme, un nucleo ovale al centro, assenza di striature. Questi muscoli sono coinvolti nel trasporto del contenuto degli organi cavi, come il cibo, attraverso l'intestino, nella regolazione della pressione sanguigna, nella costrizione e dilatazione della pupilla e in altri movimenti involontari all'interno del corpo. I muscoli lisci si contraggono sotto l'influenza del sistema nervoso autonomo. Caratterizzato da contrazioni ritmiche lente che non provocano affaticamento.
- Muscolo cardiaco. Esiste solo nel cuore. Questo muscolo si contrae instancabilmente per tutta la vita, garantendo il movimento del sangue attraverso i vasi e la consegna di sostanze vitali ai tessuti. Il muscolo cardiaco si contrae spontaneamente e il sistema nervoso autonomo regola solo il suo lavoro.
Nel corpo umano ci sono circa 400 muscoli striati, la cui contrazione è controllata dal sistema nervoso centrale.
Lezione n. 2
Anatomia funzionale del sistema muscolare. Il muscolo come organo. Classificazione dei muscoli. Sviluppo dei muscoli scheletrici. Elementi di biomeccanica muscolare. Opere di P.F. Lesgafta. Muscoli, fascia e formazioni topografiche della testa e del collo.
Funzioni del sistema muscolare
1. Locomozione (movimento del corpo e delle sue parti nello spazio).
2. Mantenere l'equilibrio del corpo.
3. Lavoro e attività cognitiva.
4. Funzione di formazione della forma (plastica).
5. Espressioni facciali.
6. Articolazione del discorso.
7. Respirazione, masticazione, deglutizione, defecazione, minzione.
8. La stampa addominale è il fattore principale nella fissazione dell'organo
cavità addominale.
9. Movimenti dei bulbi oculari.
10. Movimenti degli ossicini uditivi.
11. Le contrazioni muscolari sono fattori nel flusso sanguigno e linfatico.
12. Partecipazione al metabolismo (metabolismo degli aminoacidi e dei carboidrati).
13. Termoregolazione: quando i muscoli si contraggono, una grande quantità di co-
quantità di calore.
Il muscolo scheletrico costituisce circa il 40% del peso corporeo; sono costituiti da
tessuto muscolare striato; sono innervati dal somatico
sistema nervoso; La maggior parte delle funzioni dei muscoli scheletrici dipende da
la nostra coscienza, motivo per cui sono chiamati muscoli volontari.
Muscolo scheletricoè un organo che ha una posizione specifica in
corpo, forma caratteristica, struttura interna, afflusso di sangue,
innervazione. Ogni muscolo ha una parte carnosa - addome(ventre) e
parte del tendine(tendo). Utilizzando i tendini muscolari
attaccati alle ossa: hanno un'origine (origo) e un attacco (insertio).
Uno dei punti di attacco è immobile(punto fisso),
secondo mobile(punto mobile). A seconda del funzionale
condizioni, i punti mobili e fissi possono cambiare posto.
L'unità strutturale e funzionale di un muscolo è il muscolo
fibra a forma di cilindro con estremità appuntite, diametro
da 10 a 100 micron, lunghezza da 10 a 30 cm.
La fibra muscolare è costituita da miosimplasto E cellule miosatelliti.
Il miosimplasto è circondato da una membrana citoplasmatica (sarcolemma),
contiene numerosi nuclei (da diverse centinaia a diversi
migliaia), citoplasma (sarcoplasma), organelli generali e speciali
appuntamenti. Fibre muscolari esaminate al microscopio
hanno striature trasversali associate all'alternanza di scuro e
dischi leggeri. Al centro di ogni disco luminoso c'è un sottile
la linea scura è un teloframma, al centro di ciascun disco scuro corre
linea sottile e luminosa – mesofragma. Striatura trasversale del muscolo
fibre è dovuta alla disposizione ordinata delle fibre contrattili
fili - miofibrille. Ogni miofibrilla ha il suo
striatura trasversale, coincidente con quella dell'intero muscolo
fibre. Le miofibrille, a loro volta, sono costituite da elementi strettamente ordinati
sistemi di miofilamenti spessi (miosina) e sottili (actina).
I miofilamenti spessi sono attaccati ai mesofragmi, quelli sottili a
teloframmi. L'area della miofibrilla tra due teloframmi
chiamato sarcomero.
Ogni fibra muscolare è circondata da un sottile tessuto connettivo
conchiglia - endomisio. Le fibre muscolari formano fasci
circondato da partizioni di tessuto connettivo più dense -
perimisio. Il muscolo nel suo insieme è circondato da un epimisio costituito da
tessuto connettivo fibroso denso. Ogni muscolo contiene
vasi sanguigni e linfatici, sensoriali, motori e
fibre nervose simpatiche autonome, sensoriali e
terminazioni nervose motorie.
Svolgono un ruolo importante nel funzionamento dei muscoli scheletrici
dispositivi ausiliari, che include:
1) fascia– svolgere funzioni di delimitazione e supporto;
2) retinacolo muscolare, i canali fibrosi e fibrosi ossei sono pre-
evitare che i tendini si spostino lateralmente, uniformando la trazione muscolare;
3) guaine tendinee sinoviali; borse sinoviali (sottocutanee
ny, sottofasciale, sottotendineo, ascellare) – elimina la tensione
zione durante i movimenti;
4) blocchi muscolari e ossa sesamoidi- Cambia direzione
il decorso dei tendini, aumentare l'angolo del suo attacco e la leva di applicazione
Ce ne sono vari classificazioni del muscolo scheletrico.
1. La forma del muscolo può essere triangolare (deltoide), quadrata
noè, a forma di diamante, trapezoidale, rotondo, dritto, a forma di verme, vermiforme
retenoide.
2. Per dimensione ci sono grandi, piccoli, lunghi, corti, larghi
alcuni muscoli.
3. In base al numero di teste o addomi, a due teste, a tre teste,
quadricipiti, muscoli digastrici.
4. Per profondità di localizzazione: superficiale, profondo, esterno,
muscoli interni.
5. Per posizione: anteriore, posteriore, mediale, laterale, superiore
zione, muscoli inferiori.
6. Secondo il rapporto tra fibre muscolari e tendini: unipennate
muscoli (m. unipennatus) – le fibre muscolari si trovano obliquamente rispetto a
cucire al tendine; muscoli bipennati (m. bipennatus) – fibre muscolari
le fibre sono attaccate al tendine obliquamente su entrambi i lati; multipennato
(m. multipennatus), quando si combinano diversi tipi di corsi di fibre.
7. Per funzione: flessori ed estensori; adduttori e abduttori;
rotanti – pronatori e supinatori; sfinteri e dilatatori; anti-
nisti e sinergisti.
8. In relazione ai giunti: monogiunto, doppio giunto, multigiunto
muscoli in piedi.
9. In relazione alle zone del corpo si distinguono i muscoli della testa, del collo e della schiena
noi, torace, addome, arti.
Il movimento è fornito dal lavoro dei muscoli, che possono essere formati da tessuto muscolare striato scheletrico, liscio e cardiaco. Il tessuto muscolare liscio forma i muscoli degli organi interni, il tessuto cardiaco forma il muscolo del cuore. Il tessuto muscolare scheletrico a strisce incrociate forma i muscoli scheletrici e alcuni organi interni, ad esempio la lingua, il terzo superiore della parete dell'esofago, ecc.).
Muscoli scheletrici fanno parte dell'apparato motorio, ne costituiscono la parte attiva. I muscoli scheletrici dell'uomo, rispetto agli animali, hanno subito profondi cambiamenti in relazione alla deambulazione eretta, alla capacità di lavorare e all'articolazione della parola.
La massa muscolare scheletrica di un uomo adulto è in media del 42%, nelle donne - 36% del peso corporeo e conta circa 400 muscoli.
Funzioni dei muscoli scheletrici:
1. Fornire movimento al corpo nel suo insieme e alle sue singole parti l'una rispetto all'altra.
2. Mantenere la postura.
3. Promuovere la circolazione sanguigna e linfatica.
4. Fornire movimenti specifici: movimenti respiratori, masticazione, deglutizione, espressioni facciali, articolazione dei suoni.
5. Influisce sulla forma e sullo sviluppo delle ossa.
6. Convertono l'energia chimica in energia termica, essendo organi di produzione di calore nel corpo.
7. Accumulano una sostanza energetica di riserva: il glicogeno dell'amido animale.
Classificazione dei muscoli scheletrici
Secondo la struttura del corpo, secondo il principio della simmetria bilaterale, i muscoli sono accoppiati o sono costituiti da due metà simmetriche.
Nel corpo umano ci sono circa 400 muscoli. Hanno forme, dimensioni, posizioni e funzioni diverse. La classificazione dei muscoli è possibile secondo diversi principi.
Per forma si distinguono i muscoli: lunghi (situati principalmente sugli arti), corti e larghi (situati principalmente sul busto)
Per posizione i muscoli si dividono in: superficiali e profondi; muscoli del tronco, muscoli della testa, muscoli del collo; muscoli degli arti.
Per funzione I muscoli sono: flessori, estensori, adduttori - abduttori, rotatori, chiusure (sfinteri) - dilatatori, elevatori - depressori, sinergici - antagonisti.
Un gruppo speciale di muscoli scheletrici sono i muscoli facciali. Non hanno un doppio attacco alle ossa, ma sono sempre attaccati alla pelle ad un'estremità. Il lavoro dei muscoli facciali determina le espressioni facciali ed è coinvolto nella masticazione e nella parola.
Struttura muscolare
Ogni muscolo è un organo separato, ad es. una formazione olistica che ha una sua forma, struttura, funzione, sviluppo, posizione specifica nel corpo ed è composta da diversi tessuti.
Ogni muscolo è costituito da fasci di fibre muscolari striate (cioè cellule muscolari) che corrono parallele tra loro. Un certo numero di tali fibre sono unite da tessuto connettivo lasso in fasci muscolari del primo ordine. Molti di questi fasci sono combinati in fasci muscolari del secondo ordine, ecc. Nelle membrane del tessuto connettivo dei fasci muscolari ci sono capillari sanguigni che forniscono i nervi muscolari, motori e sensoriali. In generale, i fasci muscolari di tutti gli ordini sono uniti da una comune membrana di tessuto connettivo, che costituisce il ventre muscolare. Il tessuto connettivo che delimita i fasci muscolari forma i tendini alle estremità del ventre muscolare. I singoli muscoli e gruppi muscolari sono circondati da membrane di tessuto connettivo dense e resistenti chiamate fascia, che facilita lo scorrimento durante la contrazione muscolare e svolge una funzione protettiva.
Ogni muscolo è abbondantemente rifornito di vasi sanguigni, linfatici e nervi, il che garantisce il normale metabolismo delle cellule muscolari.
Funzionalmente, ogni muscolo ha una parte attiva che può contrarsi - l'addome, e una parte passiva - i tendini, attraverso i quali il muscolo è attaccato alle ossa.
Tessuto muscolare scheletrico a strisce incrociate, la cui proprietà è la contrattilità e determina le proprietà dei muscoli come organo di contrazione.
Lavoro muscolare
Le principali proprietà del tessuto muscolare sono l'eccitabilità, la conduttività e la contrattilità. Il lavoro dei muscoli si basa su queste proprietà.
Per effetto della contrazione il ventre muscolare si accorcia e i due punti di inserzione muscolare si avvicinano (il punto mobile si avvicina a quello stazionario). Di conseguenza, il movimento avviene in questa parte del corpo.
Di norma, più muscoli sono coinvolti contemporaneamente nell'esecuzione di un movimento. I muscoli che eseguono simultaneamente movimenti in una direzione sono chiamati sinergici (ad esempio, flessori della spalla). I muscoli che eseguono movimenti in direzioni opposte sono chiamati antagonisti (ad esempio, i muscoli flessori-estensori della spalla).
I muscoli lavorano di riflesso, cioè contrarre sotto l'influenza degli impulsi nervosi provenienti dal sistema nervoso centrale lungo gli assoni dei motoneuroni verso ciascuna cellula muscolare. Sotto l'influenza di un impulso nervoso ricevuto da una cellula muscolare, nella sua membrana si forma un potenziale d'azione e vengono rilasciati ioni calcio. Gli ioni di calcio innescano l'intero meccanismo di contrazione delle cellule muscolari. Il muscolo risponde ad ogni singolo impulso nervoso con una contrazione. La natura della contrazione muscolare dipende dalla frequenza degli impulsi nervosi in arrivo e dalla durata del loro arrivo.
In condizioni naturali, un muscolo contratto si trova in uno stato di tetano (forte contrazione prolungata) con una frequenza di impulsi nervosi di 40-50 al secondo. Il tetano si verifica a causa della somma delle contrazioni muscolari individuali. Ad una frequenza di 10-20 impulsi/sec il muscolo è in uno stato di tono, cioè una certa contrazione, necessaria per mantenere la postura ed eseguire i movimenti.
Leggi anche...
- Consultazione per i genitori "giochi intellettuali per sviluppare il pensiero dei bambini in età prescolare più grandi" Il gioco verbale completa la frase per i bambini in età prescolare
- Quiz inglese: domande di base e caratteristiche dell'organizzazione
- Olga Golodets: biografia, vita personale, famiglia, marito, figli - foto
- Yuri Konstantinovich Shafranik: biografia dell'olio di Shafranik