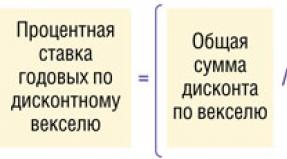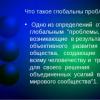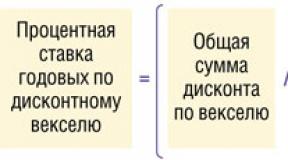Il sintomo principale di un coma. Cause, sintomi, diagnosi e trattamento degli stati comatosi. Principi di trattamento del coma
Le principali cause di coma sono le lesioni del sistema nervoso centrale, che possono essere organiche, con una violazione della struttura del cervello o funzionali. Si verifica a causa di lesioni, disturbi metabolici, shock e insufficienza di organi vitali. Il coma è una condizione patologica che si manifesta con perdita di coscienza di vario grado di gravità, fino all'assenza di attività bioelettrica del cervello, che può essere fatale.
Cause degli stati comatosi
Il coma si sviluppa quando il sistema nervoso centrale, cioè il cervello, fallisce. Ciò è causato da vari tipi di intossicazione (endogena ed esogena), lesioni cerebrali traumatiche, sepsi e insufficienza vascolare acuta (shock). Le cause del coma possono essere direttamente collegate al cervello e talvolta sono una conseguenza del fallimento di organi vitali: cuore, fegato, reni, polmoni.
Le principali cause degli stati comatosi:
- Uremia (accumulo di scorie azotate nel sangue) dovuta a insufficienza renale.
- Iperammoniemia nell'insufficienza epatica.
- Chetoacidosi.
- Ipoglicemia.
- Lesioni cerebrali traumatiche, tumori cerebrali.
- Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale: encefalite,.
- Compromissione della circolazione cerebrale nell'ictus ischemico ed emorragico.
- Ipossia prolungata con shock, soffocamento, insufficienza respiratoria acuta.
Intossicazione endogena ed esogena
Le intossicazioni endogene spesso portano al coma, le cui cause sono il fallimento degli organi che svolgono la funzione di disintossicazione. Con il coma epatico nel sangue si accumulano prodotti tossici (cadaverina, putrescina, fenoli, mercaptani, ammoniaca), che si formano nell'intestino.
In condizioni normali, il fegato lega le tossine e le converte in uno stato solubile, in cui vengono escrete nelle urine. Nella cirrosi e nell'epatite acuta, le sostanze tossiche provenienti dal tratto digestivo attraverso la vena porta non vengono neutralizzate e circolano nel flusso sanguigno. Allo stesso tempo, dal paziente emana un dolce odore di fegato. I veleni endogeni entrano nel cervello attraverso la barriera ematoencefalica, causando l'inibizione della corteccia, che porta alla perdita di coscienza (coma).
 Il coma uremico è causato da insufficienza renale dovuta a glomerulonefrite, disidratazione, porfiria e altre condizioni patologiche. I prodotti del metabolismo dell'azoto (creatinina, urea, ammoniaca) si accumulano nel sangue. I pazienti con coma uremico presentano sintomi quali:
Il coma uremico è causato da insufficienza renale dovuta a glomerulonefrite, disidratazione, porfiria e altre condizioni patologiche. I prodotti del metabolismo dell'azoto (creatinina, urea, ammoniaca) si accumulano nel sangue. I pazienti con coma uremico presentano sintomi quali:
- odore di urina;
- graffi sulla pelle;
- in polvere con cristalli di acido urico (con l'uremia, i prodotti di scarto vengono rilasciati attraverso la pelle)
- irritazione e infiammazione delle mucose del tratto gastrointestinale;
- vomito.
I composti tossici penetrano bene attraverso la barriera cerebrale e causano l'inibizione della corteccia cerebrale, che porta al coma.
La chetoacidosi si verifica in entrambi i tipi di diabete mellito. Il glucosio non passa nelle cellule, il che porta ad un passaggio del metabolismo dai carboidrati ai grassi. Gli acidi grassi vengono ossidati, formando corpi chetonici, che sono tossici per il sistema nervoso. Portano all'inibizione della corteccia cerebrale, alla disfunzione del centro respiratorio (il paziente sviluppa la respirazione di Cheyne-Stokes). Il vomito acetonemico è uno dei sintomi del coma chetoacidotico. Se si perde conoscenza, il vomito può entrare nei bronchi e causare polmonite.
L'avvelenamento con sostanze organofosforiche, metalli pesanti, pesticidi ed erbicidi può causare danni al cervello e agli organi di disintossicazione: fegato e reni.
Ipossia
Il cervello è sensibile alla mancanza di ossigeno. Pertanto, l'ipossia porta al coma. Le cause dell'ipossia sono associate ad anemia grave, shock e insufficienza respiratoria. Ciò provoca un'eccessiva perdita di sangue (shock emorragico) e ipovolemia (perdita di liquidi).
Danno cerebrale
Uno stato comatoso può essere causato direttamente da un danno cerebrale, che si verifica a seguito di tali malattie:
- meningite;
- encefalite;
- infortuni;
- tumori.
L'infiammazione del cervello e delle sue membrane si verifica durante la sepsi (avvelenamento del sangue), così come l'infezione da meningococco, l'infezione da un virus.
L'ictus emorragico e ischemico portano al coma e al fallimento della funzione cerebrale. L'ictus ischemico si verifica spesso a causa di trombosi arteriosa. La causa dell'ictus emorragico risiede solitamente nell'aumento della pressione sanguigna e nella fragilità dei vasi sanguigni.
Diagnosi e trattamento
La gravità delle condizioni del paziente e la profondità del coma sono valutate da un medico di base, un neurologo o un rianimatore. Vengono controllati i riflessi (occhio, tendine), la sensibilità della pelle e la reazione al dolore. Viene eseguita un'ecografia o una TAC. Il gold standard è la risonanza magnetica per escludere lesioni cerebrali organiche come traumi, ictus, tumori.
La diagnosi degli stati comatosi comprende un'analisi generale del sangue e delle urine. In base ai sintomi, viene prescritto un esame del sangue biochimico per corpi chetonici, enzimi epatici, bilirubina, urea e creatinina. Se si sospetta meningite o encefalite, viene eseguita una funzione diagnostica spinale.
Negli stati comatosi, la rianimazione del paziente viene effettuata nell'unità di terapia intensiva. La terapia intensiva per gli stati comatosi comprende l'emodialisi, l'ossigenazione e altre misure volte ad eliminare la causa. In uno stato comatoso, il trattamento dipende dal fattore dannoso:
- In caso di coma uremico, viene prescritta la dialisi del sangue utilizzando un rene artificiale.
- Il coma epatico viene trattato con lattulosio, che riduce l'assorbimento dell'ammoniaca. Viene prescritto anche l'antibiotico Rifaximina, che inibisce la microflora putrefattiva e aumenta l'attività degli enzimi epatici.
- Se si sviluppa ipovolemia o shock, soluzioni di cristalloidi e colloidi vengono infuse per via endovenosa.
Prendersi cura di un paziente in coma comprende il posizionamento di un catetere urinario, misure igieniche, la prevenzione delle piaghe da decubito (utilizzando materassi antidecubito) e il giramento del paziente. Poiché il coma è pericoloso per la vita, i pazienti sono costantemente sotto stretto controllo del personale medico.
COMA
DEFINIZIONE.
"Coma" è tradotto dal greco antico come sonno profondo. Secondo la definizione classica, questo termine denota il grado più significativo di inibizione patologica del sistema nervoso centrale (SNC), caratterizzato da una profonda perdita di coscienza, mancanza di riflessi agli stimoli esterni e un disturbo nella regolazione delle funzioni vitali del corpo.
Tuttavia, a causa dell'importanza di questa diagnosi per la pratica, del pericolo di vita di questa condizione e della necessità di un trattamento precoce, nella pratica il coma viene diagnosticato anche con una depressione meno pronunciata del sistema nervoso centrale, se considerato come uno stadio di il suo sviluppo. Pertanto, è più appropriato determinare a cui Come:
uno stato di insufficienza cerebrale, caratterizzato da una violazione dell'attività di coordinamento del sistema nervoso centrale, dissociazione del corpo in sistemi separati, funzionanti in modo autonomo, che a livello dell'intero organismo perdono la capacità di autoregolarsi e mantenere l'omeostasi; clinicamente, il coma si manifesta con perdita di coscienza, compromissione delle funzioni motorie, sensoriali e somatiche, comprese quelle vitali.
PRINCIPALI CAUSE DI COMPOSIZIONE E PATOGENESI.
Gli stati comatosi si sviluppano a causa di varie cause, che possono essere raggruppate in quattro gruppi:
a) processi intracranici (vascolari, infiammatori, volumetrici, ecc.);
b) condizioni ipossiche durante
Patologia somatica (ipossia respiratoria con danno all'apparato respiratorio, ipossia circolatoria con disturbi circolatori, ipossia emica con patologia dell'emoglobina),
Disturbi della respirazione tissutale (ipossia tissutale),
Un calo della tensione dell'ossigeno nell'aria inalata (ipossia ipossica);
c) disturbi metabolici (principalmente di origine endocrina);
d) intossicazione (sia esogena che endogena).
Nonostante tutta la diversità dell'eziologia degli stati comatosi, la loro patogenesi ha molto in comune e i fattori che fungono da cause primarie di alcuni tipi di coma agiscono come meccanismi patogenetici in altri. Il meccanismo diretto dell'insufficienza cerebrale è una violazione della formazione, distribuzione e trasmissione degli impulsi nervosi nelle cellule cerebrali a causa della depressione della respirazione, del metabolismo e dell'energia dei tessuti. Ciò si verifica a causa di una riduzione dell'apporto di ossigeno e sostanze nutritive al tessuto cerebrale (ischemia, congestione venosa, disturbi della microcircolazione, stasi vascolare, edema perivascolare), cambiamenti nell'equilibrio acido-base ed elettrolitico, aumento della pressione intracranica, edema e gonfiore del cervello il cervello e le meningi. Quest'ultimo può portare alla dislocazione del cervello con danni meccanici ai tessuti dei centri vitali. Con qualsiasi coma, in uno stadio o nell'altro, si sviluppa ipossia tissutale di varia gravità. I disturbi dello stato acido-base hanno molto spesso il carattere dell'acidosi metabolica; con danno primario al sistema respiratorio, si sviluppa acidosi respiratoria. Meno comunemente, ad esempio, in caso di vomito persistente si verifica alcalosi metabolica e l'iperventilazione porta ad alcalosi respiratoria. È caratteristica una combinazione di vari cambiamenti metabolici e respiratori. Tra i disturbi elettrolitici, i più significativi sono i cambiamenti nella concentrazione di potassio (sia ipo che iperkaliemia) e iponatriemia. Quest'ultimo gioca un ruolo importante nell'aumento dell'edema cerebrale. I disordini metabolici progressivi hanno un effetto istotossico. Man mano che il coma si approfondisce, si sviluppano problemi respiratori e successivamente di circolazione sanguigna.
Classificazione.
A seconda dei fattori causali, ci sono "primario" E "secondario" coma (vedere Tabella 1).
Per valutare la prognosi e scegliere le tattiche terapeutiche, è molto importante determinare cosa ha portato allo sviluppo di un coma: danno cerebrale focale con effetto massa, danno al tronco encefalico o danno diffuso alla corteccia e al tronco encefalico. Inoltre, le prime due opzioni sono caratteristiche di quelle primarie e l'ultima si verifica quasi esclusivamente nei coma secondari.
Spegnere la coscienza - stordire- può avere diverse profondità, a seconda di quale è suddiviso in:
obnibulazione - annebbiamento, stupore, “coscienza annebbiata”, stordimento,
dubbio - sonnolenza,
stupore: perdita di coscienza, insensibilità, ibernazione patologica, profondo stupore,
a chi - il grado più profondo di insufficienza cerebrale.
Di norma, invece delle prime tre opzioni, viene fatta la diagnosi di "precoma".
In medicina i segni di una chiara coscienza sono considerati la capacità di una persona di rispondere in modo significativo e adeguato agli stimoli esterni rimanendo intatta e orientata nell’ambiente circostante (luogo, tempo) e nella propria personalità. La coscienza viene valutata in termini del suo contenuto e del suo livello di attivazione. Su questa base i disturbi della coscienza vengono convenzionalmente suddivisi in stupore, confusione e perdita di coscienza. L'oscurità e la confusione della coscienza (stato crepuscolare, delirio, oniroide) sono caratterizzate da una violazione del suo lato contenutistico, perdita di lucidità di pensiero, mentre un sintomo comune delle sindromi di spegnimento (depressione) della coscienza è una diminuzione del livello della sua attivazione, vale a dire diminuzione del livello generale di veglia. A seconda del grado di tale diminuzione, vengono diagnosticati stupore, stupore e coma.
Stordire– spegnimento parziale della coscienza, caratterizzato da una violazione del livello di attenzione, vale a dire la capacità di selezionare le informazioni necessarie e produrre pensieri e azioni coerenti e logicamente coerenti in risposta. Il contatto verbale con il paziente è preservato, tuttavia si nota un aumento della soglia di tutti gli stimoli esterni e una diminuzione della propria attività: il paziente apre gli occhi in risposta a qualcuno che si rivolge a lui, risponde a semplici domande e segue semplici istruzioni; reagisce al dolore in modo coordinato, ma tutte le sue reazioni sono monosillabiche e lente. Il paziente non è in grado di eseguire un compito che richiede un'attenzione prolungata, ad esempio sottraendo costantemente da centosette.
Sopore– spegnimento della coscienza, caratterizzato dalla cessazione del contatto verbale pur mantenendo la reazione sotto forma di apertura degli occhi a forti stimoli esterni e la presenza di una reazione motoria coordinata protettiva al dolore.
Coma– la chiusura più profonda della coscienza, in cui il contatto verbale con il paziente è impossibile, non si aprono gli occhi alla stimolazione afferente e le reazioni difensive agli stimoli dolorosi sono scoordinate.
È consuetudine distinguere tre gradi di coma: lieve, grave e profondo.
Il coma lieve o di grado 1 è caratterizzato dalla comparsa di irrequietezza motoria generale o dal ritiro di un arto in risposta ad uno stimolo doloroso. I riflessi corneali e le reazioni pupillari alla luce vengono preservati, la deglutizione non viene compromessa, la respirazione e la circolazione sanguigna sono sufficienti per mantenere le funzioni vitali del corpo. La minzione non è volontaria; Possibile ritenzione urinaria.
Il coma grave o di secondo grado è determinato dalla completa assenza di risposta motoria a stimoli dolorosi sonori e moderati e dalla presenza di riflessi protettivi a forti stimoli dolorosi. Si osservano tipi patologici di respirazione, ipotensione arteriosa e disturbi del ritmo cardiaco. Le pupille sono spesso strette, meno spesso larghe, le loro reazioni alla luce e i riflessi corneali sono ridotti. La deglutizione è compromessa, ma quando il liquido entra nelle vie respiratorie si verificano movimenti di tosse, che indicano una parziale conservazione delle funzioni bulbari. I riflessi profondi sono depressi.
Grado profondo o III - caratterizzato dall'estinzione di tutti, compresi gli atti riflessi vitali. La respirazione non è adeguata, l’attività cardiaca è ridotta. Non vengono evocate reazioni motorie, si determina ipotonia muscolare. Si osserva la posizione centrale dei bulbi oculari, le pupille sono larghe, la loro reazione alla luce e i riflessi corneali sono assenti.
Per la valutazione quantitativa vengono utilizzate varie scale; la più famosa è la scala Glasgow (Tabella 1). La condizione dei pazienti viene valutata al momento del ricovero e dopo 24 ore secondo tre parametri: apertura degli occhi al suono o al dolore, risposta verbale agli stimoli esterni, risposta motoria agli stimoli esterni.
SCALA DELLA PROFONDITÀ DELLE CONDIZIONI COMATOSE
(Glasgow-Pittsburgh) .Tabella 1.
|
Natura della reazione | ||
|
Aprendo gli occhi |
Apertura spontanea In risposta alle istruzioni verbali In risposta alla stimolazione dolorosa Assente | |
|
Attività fisica |
Risposta mirata alle istruzioni verbali Risposta mirata alla stimolazione ("ritiro dell'arto") Risposta mirata alla stimolazione dolorosa (“ritiro con flessione dell’arto”) Movimenti patologici di flessione tonica in risposta alla stimolazione dolorosa Movimenti patologici di estensione tonica in risposta alla stimolazione dolorosa Mancanza di risposta motoria in risposta alla stimolazione dolorosa | |
|
Risposte verbali |
Mantenere l'orientamento, risposte rapide e corrette Discorso confuso Alcune parole incomprensibili, produzione vocale inadeguata Suoni inarticolati Mancanza di parola |
Nota: per determinare il grado di depressione della coscienza è necessario sommare i punti che determinano lo stato di ciascuna delle tre funzioni proposte.
Conformità delle caratteristiche secondo la scala Glasgow con i criteri tradizionali
Tuttavia, non esistono distinzioni patogenetiche (che in una certa misura possono essere attribuite a classificazioni della profondità del coma) e cliniche chiaramente definite tra i quattro gradi di stordimento, e quindi, indipendentemente dal grado di perdita di coscienza, l'uso del termine è consentito coma , la cui profondità può essere valutata con un semplice ma informativo
scala clinica (Tabella 1).
CLASSIFICAZIONE DELLE COMA A SECONDA DELLE CAUSE CHE LE SONO
|
R. Primaria |
B. Coma a seguito di danno secondario al sistema nervoso centrale |
|
|
coma cerebrale ("coma cerebrale") |
a) fattori endogeni |
b) fattori esterni |
|
Cerebrovascolare (a seguito di ictus ischemico o emorragico, emorragia subaracnoidea), Epilettico, Con processi occupanti spazio intracranici (tumori, echinococcosi, ascessi), In caso di danno infettivo al tessuto cerebrale o alle meningi, Traumatico. |
In caso di insufficienza della funzione degli organi interni (uremica, epatica, ipossica a causa di danni al sistema respiratorio o circolatorio), Per le malattie del sistema endocrino (diabetico, ipotiroideo e tireotossico, ipocorticoide, ecc.), Per le neoplasie (ipoglicemia con tumore ormonalmente attivo delle cellule β pancreatiche o tumori maligni massicci ormonalmente inattivi), Per altre malattie terapeutiche, chirurgiche, infettive e di altro tipo (malarica, anemia perniciosa, ecc.). |
In caso di sovradosaggio relativo o assoluto di farmaci ipoglicemizzanti (ipoglicemizzanti), Durante il digiuno (distrofico alimentare), In caso di intossicazione (alcol, oppiacei, barbiturici, avvelenamento con tranquillanti, metanolo, monossido di carbonio, ecc.), In caso di surriscaldamento (ipertermico o "colpo di calore"), In caso di ipotermia, In caso di lesioni elettriche, ecc. |
POSSIBILI COMPLICAZIONI.
Tra le complicanze del coma importanti nella fase preospedaliera possiamo evidenziare approssimativamente:
condizioni e sindromi associate direttamente a danno cerebrale e gonfiore;
condizioni patologiche e reazioni causate da una violazione della funzione regolatrice del sistema nervoso centrale.
I primi includono complicazioni gravi come:
vari disturbi respiratori fino alla cessazione;
disturbi emodinamici, manifestati sia da iper- che da ipotensione arteriosa, edema polmonare e arresto cardiaco;
ipertermia centrale.
I secondi, pur essendo di natura “periferica”, possono essere anche fatali:
vomito con aspirazione di vomito nelle vie respiratorie e sviluppo di asfissia o sindrome di Mendelssohn (insufficienza respiratoria acuta dovuta a broncoostruzione e successivo edema polmonare tossico quando il contenuto gastrico acido entra nel sistema respiratorio);
ritenzione urinaria acuta (“vescica neurogena”) con possibilità di rottura della vescica;
Cambiamenti dell'ECG che, a differenza della sindrome da "infarto-ictus", hanno la natura della distrofia miocardica: vari cambiamenti nell'onda T e nel segmento ST, aumento dell'ampiezza dell'onda U, prolungamento della sistole elettrica e del QT intervallo; A volte possono apparire cambiamenti simili a un infarto.
STRUTTURA CHIAMATA “03”.
Secondo i nostri dati, ottenuti dall'analisi del lavoro del Servizio medico di emergenza di Mosca, la frequenza del coma nella fase preospedaliera è di 5,8 per 1000 chiamate. La causa più comune di coma è l'ictus - 57,2%, l'overdose da farmaci è al secondo posto - 14,5%, seguita dal coma ipoglicemico - 5,7%, trauma cranico - 3,1%, coma diabetico e avvelenamento da farmaci - 2,5% ciascuno, coma alcolico - 1,3%; Il coma è stato diagnosticato molto raramente a causa di avvelenamento da vari veleni - 0,6%; Molto spesso, la causa del coma nella fase preospedaliera rimaneva non solo poco chiara, ma addirittura insospettata (coma di origine sconosciuta) - 11,9%. Allo stesso tempo, la mortalità preospedaliera raggiunge il 4,4%.
Cos'è il coma?
Coma chiamato stato inconscio con una profonda compromissione dei riflessi e mancanza di risposta alla stimolazione.
Il sintomo generale e principale del coma stato di qualsiasi origine è una profonda perdita di coscienza causata da danni a parti vitali del cervello.
Qual è la patogenesi degli stati comatosi?
Nella patogenesi degli stati comatosi, i disturbi circolatori nel cervello e il danno tossico alle cellule del sistema nervoso centrale sono di primaria importanza. Più spesso comatoso stato osservato in accidenti cerebrovascolari acuti, diabete mellito, nefrite cronica, aumento dell'insufficienza epatica, avvelenamento grave.
Quali sono i sintomi del precoma?
Il coma può verificarsi all'improvviso nel bel mezzo di un relativo benessere. Lo sviluppo acuto è tipico del coma cerebrale durante l'ictus, coma ipoglicemico. Tuttavia, in molti casi, un coma, complicando il decorso della malattia, si sviluppa gradualmente (con coma diabetico, uremico, epatico e molti altri coma stati). In questi casi il coma, una profonda perdita di coscienza, è preceduto da uno stadio di precoma. Sullo sfondo di una crescente esacerbazione dei sintomi della malattia di base, compaiono segni di danno al sistema nervoso centrale sotto forma di stupore, letargia, indifferenza, confusione con schiarimenti periodici. Tuttavia, durante questo periodo, i pazienti mantengono la capacità di rispondere a forti irritazioni, tardivamente, a monosillabi, ma rispondono comunque a una domanda posta ad alta voce e mantengono i riflessi pupillari, corneali e di deglutizione; Conoscere i sintomi della precomatosi stato Ciò è particolarmente importante, poiché spesso l'assistenza tempestiva durante questo periodo di malattia impedisce lo sviluppo del coma e salva la vita del paziente.
Quali sono le caratteristiche distintive stato pelle di un paziente con coma di varia eziologia?
Quando si esamina la pelle, si dovrebbe tenere conto del fatto che con uremia, trombosi dei vasi cerebrali e anemia, la pelle è pallida. Nel coma alcolico o nell'emorragia cerebrale, il viso è solitamente iperemico. La colorazione rosa della pelle è caratteristica del coma dovuto ad avvelenamento da monossido di carbonio. Il giallo della pelle si osserva solitamente nel coma epatico. È importante determinare il contenuto di umidità della pelle di un paziente in coma. La pelle umida e sudata è caratteristica di un coma ipoglicemico. In un coma diabetico, la pelle è sempre secca. Tracce di vecchi graffi sulla pelle possono essere notate in pazienti con coma diabetico, epatico e uremico. Foruncoli freschi, così come cicatrici cutanee da vecchi foruncoli riscontrati in pazienti in coma, suggeriscono il diabete mellito.
Di particolare importanza è lo studio del turgore cutaneo. In alcune malattie accompagnate da disidratazione del corpo e che portano allo sviluppo del coma, si osserva una significativa diminuzione del turgore della pelle. Questo sintomo è particolarmente pronunciato nel coma diabetico. Una simile diminuzione del turgore dei bulbi oculari nel coma diabetico li rende morbidi, cosa che può essere facilmente determinata dalla palpazione.
Quali sono le caratteristiche distintive delle mucose nei coma di diverse eziologie?
Quando si esamina le mucose, è necessario prestare attenzione al colore e al grado di umidità. L'ittero della sclera viene solitamente rilevato nel coma epatico e nell'anemia. Quando si esamina la lingua, la presenza di morsi freschi e cicatrici di vecchi morsi dovrebbe suggerire l'epilessia. Il coma uremico è caratterizzato da un'insolita secchezza della lingua. Un grave gonfiore del tessuto sottocutaneo può essere rilevato in pazienti con coma uremico ed epatico. In quest'ultimo caso, l'edema è combinato con l'ascite.
Quali sono le caratteristiche della respirazione di un paziente nei vari tipi di coma?
Per il coma stato caratterizzato da una violazione del ritmo respiratorio. Nel coma diabetico ed epatico si osserva spesso un respiro ampio e rumoroso di Kussmaul. Con un coma cerebrale, di solito appare la respirazione russante. Spesso, nei pazienti in coma, si osserva la respirazione di Cheyne-Stokes con un graduale aumento e quindi un indebolimento della profondità dei movimenti respiratori fino alla comparsa di una pausa nei movimenti respiratori (periodo di apnea).
Determinare l'odore dell'aria espirata da un paziente ha un importante valore diagnostico. Il coma uremico è caratterizzato dall'odore di ammoniaca, a volte così forte da essere percepito già entrando nella stanza in cui giace il paziente. Nel coma diabetico, nell'aria espirata si rileva quasi sempre l'odore dell'acetone, che ricorda l'odore delle mele leggermente mature.
Quali sono le caratteristiche stato sistema cardiovascolare in coma di varia eziologia?
Lo studio del polso e della pressione sanguigna nei pazienti in coma è di grande importanza. Bradicardia con tensione del polso e ipertensione si osserva nell'eclampsia e nelle fasi iniziali del coma cerebrale. L'elevata ipertensione arteriosa viene solitamente rilevata nei pazienti con coma uremico. Nel coma diabetico si determinano bassa pressione sanguigna e tachicardia. Il rilevamento di gravi sintomi neurologici sotto forma di emiplegia o emiparesi indica un incidente cerebrovascolare acuto come causa del coma.
Come viene fornita l'assistenza ad un paziente in coma diabetico?
Il trattamento del coma dipende dalla natura della malattia di base. In coma diabetico, al paziente viene somministrata insulina per via sottocutanea e endovenosa, bicarbonato di sodio e soluzione salina come prescritto dal medico.
Come viene fornita l'assistenza a un paziente in coma ipoglicemico?
Il coma ipoglicemico è preceduto da una sensazione di fame, debolezza e tremore in tutto il corpo. Prima dell'arrivo del medico, al paziente viene somministrato zucchero o tè dolce. 20-40 ml di soluzione di glucosio al 40% vengono iniettati in una vena.
Come vengono fornite le cure di emergenza a un paziente in coma uremico?
Nel coma uremico, le misure terapeutiche mirano a ridurre l'intossicazione. A tale scopo si lava lo stomaco, si fa un clistere detergente, si iniettano goccia a goccia una soluzione isotonica di cloruro di sodio e una soluzione di glucosio al 5%.
Come vengono fornite le cure di emergenza a un paziente in coma epatico?
In caso di coma epatico si somministrano gocce di soluzioni di glucosio, ormoni steroidei e vitamine secondo la prescrizione del medico.
Gli stati comatosi che si verificano a seguito di vari processi patologici possono essere suddivisi nei seguenti gruppi.
Causato da danno primario al sistema nervoso centrale (neurogenico). Questo gruppo include il coma che si sviluppa con ictus, lesioni cerebrali traumatiche, epilessia, infiammazioni e tumori del cervello e delle sue membrane.
Sviluppo a causa di disturbi dello scambio di gas.
† Ipossico. Associato ad un apporto insufficiente di ossigeno dall'esterno (soffocamento) o ad un trasporto compromesso di ossigeno in gravi disturbi circolatori acuti e anemia.
† Respiratorio. Causato da ipossia, ipercapnia e acidosi dovuti a disturbi significativi nello scambio di gas polmonare durante l'insufficienza respiratoria.
Causato da disturbi metabolici dovuti a produzione insufficiente o eccessiva di ormoni (coma diabetico, ipotiroideo, ipocorticoide, ipopituitario), sovradosaggio di farmaci ormonali (coma tireotossico, ipoglicemico).
Coma tossigeni associati a intossicazione endogena dovuta a infezioni tossiche, insufficienza epatica e renale (coma epatico, uremico), pancreatite o con esposizione a veleni esogeni (coma dovuto a avvelenamento, compreso alcol, FOS, ecc.).
Causata primaria dalla perdita di acqua, elettroliti e sostanze energetiche (coma iponatremico con sindrome da inadeguata produzione di ADH, coma cloridpenico, che si sviluppa in pazienti con vomito persistente, coma nutrizionale-distrofico o affamato).
Coscienza compromessa
Il grado di compromissione della coscienza gioca spesso un ruolo decisivo nell'esito di molte malattie e processi patologici. Pertanto, la determinazione dello stato di coscienza è uno dei punti principali durante l'esame di un paziente, soprattutto in situazioni di emergenza. I disturbi (disturbi) della coscienza sono elencati in Fig. 20–12
Riso. 20–12. Principali tipologie di disturbi della coscienza.
I disturbi della coscienza sono generalmente suddivisi in cambiamenti della coscienza e depressione della coscienza.
Cambiamenti nella coscienza- forme produttive di disturbo della coscienza che si sviluppano sullo sfondo della veglia. Sono caratterizzati da un disturbo delle funzioni mentali, da una percezione distorta dell’ambiente e della propria personalità e di solito non sono accompagnati dall’immobilità. Questi includono delirio, amentia e disturbi crepuscolari della coscienza. Sono le principali manifestazioni della maggior parte delle malattie mentali e sono prese in considerazione in psichiatria.
Oppressione della coscienza- forme improduttive di compromissione della coscienza, caratterizzate da un deficit dell'attività mentale con una diminuzione del livello di veglia, una netta depressione delle funzioni intellettuali e dell'attività motoria.
Per determinare il grado di depressione della coscienza, la cosiddetta scala si è dimostrata efficace Glasgow(Scala scozzese, vedere l'articolo “Scala” nell'Appendice “Riferimento dei termini” sul CD). Il grado di depressione della coscienza viene valutato in punti.
Alcuni tipi di disturbi della coscienza
Stordireè il risultato di un aumento (sotto l'influenza di un fattore patogeno) della soglia di eccitabilità. A questo proposito, lo stordimento è caratterizzato da una diminuzione della sensibilità del corpo agli stimoli esterni.
Manifestazioni
Quando viene stordito, viene notato quanto segue:
† Mantenere la coscienza sullo sfondo di vari gradi di interruzione della coerenza, della logica e della chiarezza del pensiero (confusione).
† Inattività fisica.
† Disorientamento nella situazione.
† Aumento della sonnolenza (dubbio). Forti stimoli (suono, luce, dolore) allontanano solo temporaneamente il paziente dallo stato di stordimento.
Uno stato di stupore spesso precede lo stupore.
Sopore- una condizione caratterizzata da inibizione generale dell'attività mentale, significativa depressione della coscienza (ma non la sua completa perdita! [a differenza del coma]), perdita di movimenti volontari, pur mantenendo i riflessi (a differenza del coma) a forti stimoli sonori, luminosi e dolorosi. Quest'ultimo è solitamente espresso da reazioni motorie a breve termine, gemiti e movimenti dei muscoli facciali.
Lo stupore è spesso considerato uno stadio nello sviluppo del coma, che precede la perdita di coscienza (cioè lo sviluppo del coma stesso).
Delirio caratterizzato da:
† falsa percezione affettiva dell'ambiente e degli eventi, del proprio ruolo in essi (illusioni),
† sensazioni visive e/o uditive endogene spontanee (allucinazioni),
† stimolazione vocale e motoria.
In uno stato di delirio, il paziente partecipa attivamente agli eventi che percepisce (può attaccare, difendersi, scappare; descrivere vividamente le immagini a lui “visibili”, “conversare” con un interlocutore assente).
Amentia caratterizzato da:
† incoerenza (discontinuità) del pensiero,
† violazione dell'orientamento, della percezione degli oggetti circostanti, degli eventi e della propria personalità;
† eccitazione caotica e disordinata;
† attività motoria non intenzionale.
† In caso di guarigione, il paziente non ricorda (amnesia) cosa gli è successo durante il periodo di amenza.
Stato crepuscolare la coscienza è caratterizzata da:
† violazione dell'orientamento nell'ambiente,
† distacco dall'attualità reale,
† comportamento basato su allucinazioni (solitamente di natura spaventosa),
† inizio e cessazione improvvisi,
† spesso commette atti aggressivi.
† L'episodio di stato crepuscolare è amnesico.
È necessario distinguere lo stupore da vari tipi di menomazione e perdita di coscienza. Durante lo stupore, la coscienza non viene persa. Lo stupore è una condizione caratterizzata da completa immobilità, indebolimento o assenza di reazioni agli stimoli sonori, luminosi e dolorosi esterni sullo sfondo della coscienza preservata.
Lo stupore si sviluppa spesso in pazienti con malattie mentali (ad esempio schizofrenia) e gravi (ad esempio con sindrome da malassorbimento grave). Lo stupore si osserva anche in una serie di stati depressivi (ad esempio, dopo la perdita di una persona cara) e in gravi traumi psicogeni che si sviluppano sotto l'influenza di vari fattori estremi.
COMA (dal greco koma - sonno profondo) è una condizione generale estremamente grave del corpo.
Si verifica a seguito dell'azione di fattori dannosi eso- ed endogeni.
Caratterizzato da perdita di coscienza
insufficienza delle funzioni degli organi e dei sistemi fisiologici del corpo.
CAUSE DEL COMA
Chi è causato da vari fattori. Solitamente si dividono in esogeni ed endogeni. Quest'ultimo può essere infettivo o non infettivo.
Fattori esogeni
I fattori esogeni (Fig. 20-13) sono agenti ambientali patogeni, solitamente di estrema forza, tossicità e/o natura distruttiva.

Riso. 20–13. Le cause esogene più comuni di coma.
Vari fattori traumatici (solitamente cerebrali) (corrente elettrica, trauma cranico meccanico).
Effetti termici (surriscaldamento, colpi di sole, ipotermia).
Fluttuazioni significative della pressione barometrica (ipo e iperbaria).
Tossine neurotropiche (alcol e suoi surrogati, glicole etilenico, dosi tossiche di farmaci, sedativi, barbiturici e alcuni altri farmaci).
Agenti infettivi (virus neurotropi, tossine botuliniche e tetaniche, agenti patogeni della malaria, febbre tifoide, colera).
Ipossia e anossia esogena.
Energia delle radiazioni (grandi dosi di radiazioni penetranti).
Fattori endogeni
I fattori endogeni (Fig. 20-14), che portano allo sviluppo del coma, sono il risultato di gravi disturbi delle funzioni vitali del corpo. Si osservano durante il decorso sfavorevole di varie malattie e condizioni dolorose. Queste condizioni portano a deviazioni significative dalla norma nei parametri e costanti vitali, eccesso o carenza di substrati metabolici e/o ossigeno nel corpo.

Riso. 20–14. Le cause endogene più comuni di coma.
Processi patologici nel cervello (ischemia, ictus, tumore, ascesso, edema, ecc.).
Insufficienza circolatoria (ipossia cerebrale).
Insufficienza respiratoria (ipossia cerebrale con stato asmatico, asfissia, edema polmonare).
Patologia del sistema sanguigno (emolisi massiccia dei globuli rossi, grave anemia).
Endocrinopatie (ipoinsulinismo, condizioni di ipo e ipertiroidismo, insufficienza surrenalica).
Insufficienza epatica, disturbi dell'apparato digerente (sindrome da malassorbimento, autointossicazione intestinale e/o autoinfezione).
Insufficienza renale.
Gli stati comatosi si sviluppano in alcuni casi con un grave decorso progressivo di collasso e shock.
Patogenesi generale e manifestazioni
La patogenesi degli stati comatosi, indipendentemente dalle cause che li hanno causati, include diversi collegamenti chiave comuni mostrati in Fig. 20–15.
Riso. 20–15. I principali collegamenti nella patogenesi degli stati comatosi.
Le manifestazioni generali degli stati comatosi sono presentate nella tabella. 20–5.
Tabella 20–5. Manifestazioni generali di stati comatosi
|
Organi e loro apparati |
Funzioni modificate |
|
Nervoso ed endocrino |
Disturbi della coscienza, perdita di conoscenza, ipo‑ e areflessia, squilibrio delle sostanze biologicamente attive e dei loro effetti. |
|
Insufficienza cardiaca, ipotensione arteriosa e collasso, ridistribuzione del flusso sanguigno, insufficienza trofica capillare, |
|
|
Insufficienza respiratoria. |
|
|
Sistema sangue ed emostasi |
Depositare sangue cambiamento nella viscosità del sangue, sindrome tromboemorragica. |
|
Insufficienza epatica. |
|
|
Insufficienza renale. |
|
|
Digestione |
Insufficienza della digestione delle cavità e delle membrane, autointossicazione intestinale, autoinfezione. |
Ipossia e disturbi nei processi di approvvigionamento energetico
L'interruzione dell'apporto di ossigeno ai tessuti e agli organi è la causa del coma e/o il suo legame patogenetico. La violazione osservata dell'apporto di substrati delle cellule provoca l'insufficienza dell'ossidazione biologica in esse.
La risintesi dell'ATP nei neuroni cerebrali è assicurata principalmente grazie all'energia dell'ossidazione del glucosio nelle reazioni di respirazione dei tessuti. I neuroni del cervello, che normalmente sono le strutture più dipendenti dall’ossigeno, in condizioni ipossiche diventano l’oggetto più vulnerabile del corpo.
† La massa cerebrale, che rappresenta circa il 2% della massa corporea, rappresenta circa il 20% (!) della gittata sanguigna cardiaca. A questo proposito, una diminuzione dell’apporto di ossigeno e/o di substrati metabolici al cervello attraverso il sangue elimina la possibilità del suo normale funzionamento.
† La cessazione della circolazione cerebrale entro 8-10 s porta a una carenza critica di ossigeno e a disturbi nell'approvvigionamento energetico dei neuroni. Il risultato è la perdita di coscienza.
† L'esaurimento del glucosio che si verifica nei successivi 4-7 minuti, nonché la soppressione (a causa dell'aumento dell'acidosi) del metabolismo anaerobico sono accompagnati dal consumo insostituibile di energia ATP. A questo proposito, l'attività specifica dei neuroni viene inibita, la coscienza viene persa e iniziano a svilupparsi processi degenerativi in rapida progressione.
† La scomposizione dei composti organici di grandi dimensioni nei neuroni, così come l'accumulo di Na + in eccesso e di alcuni altri ioni in essi, porta ad un aumento significativo della pressione osmotica e oncotica intracellulare. Ciò a sua volta porta all'iperidratazione delle cellule nervose, combinata con il rilascio di liquido dai vasi nell'interstizio (cioè edema cerebrale), iperemia venosa ed emorragie nella sostanza cerebrale.
I neuroni cerebrali sono più danneggiati in condizioni di ischemia che di ipossiemia. Con normale pressione di perfusione nei vasi cerebrali, anche con una diminuzione della p a O 2 fino a 30 mm Hg. e sotto non ci sono segni di distruzione neuronale.
La violazione dell'approvvigionamento energetico delle cellule alla fine provoca la loro disfunzione, lo sviluppo della distrofia e il disordine dei processi plastici in esse. Questo è più pronunciato nel cervello e nel cuore. A questo proposito, nei pazienti in coma, la coscienza è persa, i riflessi sono ridotti o assenti; si sviluppano aritmie e insufficienza della funzione contrattile cardiaca, nonché ipotensione arteriosa; la frequenza e la periodicità del funzionamento dei neuroni del centro respiratorio vengono interrotte, il volume della ventilazione alveolare diminuisce, il che porta all'insufficienza respiratoria e al peggioramento dell'ipossia.
Intossicazione
Il coma di qualsiasi origine è caratterizzato dall'accumulo di sostanze tossiche nel corpo. Entrano nell'organismo dall'esterno (con coma di origine esogena) e si formano al suo interno (con coma endogeno). Un certo numero di stati comatosi sono causati da tossine neurotropiche, alcol e suoi surrogati, glicole etilenico e tossine fungine; Medicinali se usati in modo errato (ad esempio farmaci, barbiturici, tranquillanti).
Le sostanze tossiche, così come i prodotti del loro metabolismo, hanno il maggiore effetto patogeno sui neuroni del tronco cerebrale e degli emisferi cerebrali, sulle ghiandole endocrine, sul cuore, sul fegato, sui reni e sulle cellule del sangue. Le tossine danneggiano le strutture della membrana e gli enzimi delle cellule. A questo proposito, la funzione dei neuroni nelle strutture corticali e sottocorticali viene soppressa. Ciò, a sua volta, porta a interruzioni dell'attività del sistema cardiovascolare, respiratorio, endocrino e digestivo, dei reni, del fegato, del sistema sanguigno, dell'emostasi, ecc.
L'intossicazione del corpo con prodotti metabolici è aggravata dall'interruzione della funzione di disintossicazione del fegato e dall'attività escretoria dei reni. Pertanto, durante un coma diabetico, i livelli di CT, acido lattico e piruvico nel sangue aumentano in modo significativo. In questo caso, ad esempio, un eccesso di acido acetoacetico sopprime significativamente l'attività dei neuroni nel cervello e nei gangli autonomici.
Con coma epatico nel sangue, il contenuto di putrescina, cadaverina, derivati fenolici, indolo, scatolo (formato nell'intestino crasso durante la scomposizione delle proteine), composti di ammonio (carbonato di ammonio e acido carbammico, idrossido di ammonio) aumenta in modo significativo Il collegamento patogenetico negli stati comatosi è l'accumulo di ammoniaca in eccesso (che inibisce la Na-K-ATPasi, forma metaboliti tossici, danneggia i recettori delle benzodiazepine e ha altri effetti patogeni). Normalmente, i composti di cui sopra vengono inattivati nel fegato ed espulsi dal corpo attraverso i reni. Tuttavia, in caso di insufficienza epatica e/o renale, questi composti tossici e i loro derivati potenziano i danni al cervello e ad altri organi, aggravando le condizioni del paziente.
Disturbi della RSI
La deviazione degli indicatori ASR è un fenomeno naturale in coma di qualsiasi origine.
Nella maggior parte dei casi si sviluppa acidosi.
† Ipossia di tipo circolatorio, respiratorio, ematico e tissutale.
† Funzione renale compromessa (inibizione dell'acidogenesi e dell'ammoniogenesi, diminuzione della funzione escretoria).
† Disfunzione epatica (soppressione del processo di inattivazione del CT). Ciò aumenta il grado di acidosi.
Molto meno spesso e, di regola, lo sviluppo di alcalosi viene registrato temporaneamente (ad esempio, durante un periodo di iperventilazione polmonare o durante un coma epatico, accompagnato da un aumento significativo del contenuto di ioni ammonio nel sangue).
Squilibrio tra ioni e acqua
Manifestazioni: Perdita cellulare di K+. Sviluppo di iperkaliemia. Aumento delle cellule. Aumento intracellulare. Iponatremia Questi cambiamenti sono una conseguenza della ridotta attività della Na + ,K + ‑ATPasi del plasmalemma e del danno alle membrane cellulari. Riduzione e/o Alcuni tipi di coma (ad esempio, renale o epatico) sono caratterizzati da altri cambiamenti nel bilancio ionico. Queste varianti dello stato comatoso possono essere accompagnate da un aumento del livello di aldosterone nel sangue (a causa della sua maggiore sintesi nelle ghiandole surrenali o della ridotta inattivazione nel fegato), causando il riassorbimento di Na+ e l'escrezione di K+ a livello renale. tubuli con sviluppo rispettivamente di ipernatriemia e ipokaliemia. Iperosmia e iperonchia. Sono il risultato dell'idrolisi di composti molecolari di grandi dimensioni (LP, proteoglicani, glicogeno e altri) in molecole medie e piccole (proteine, aminoacidi, glucosio, LA).
Conseguenze: Iperidratazione delle cellule cerebrali e di altri organi (nel coma diabetico iperosmolare, al contrario, si sviluppa l'ipoidratazione delle cellule, potenziandone il danno). Aumento del contenuto di liquidi nello spazio intercellulare. Un aumento del volume del liquido nel letto vascolare (ipervolemia). Edema del cervello e dei polmoni. Diarrea, vomito, poliuria (ad esempio, nel coma ipocloremico, diabetico, iperosmolare). Possono causare una progressiva ipoidratazione extracellulare e poi totale. Aumento significativo della viscosità del sangue. Violazione del tessuto organico e della microemocircolazione. Aggregazione disseminata delle cellule del sangue, sua ipercoagulazione e trombosi (sindrome DIC).
Disturbi dell'elettrogenesi
Manifestazioni
L'interruzione dei processi di fornitura di energia alle cellule, il danneggiamento delle loro membrane e degli enzimi durante il coma provoca naturalmente disturbi: la formazione di MP e PD. eccitabilità (diminuzione, aumento). effettuare l'eccitazione. Ciò si manifesta maggiormente nelle strutture del cervello e del cuore.
Conseguenze: perdita di coscienza, perfino perdita di coscienza. Disturbi delle funzioni dei centri nervosi (principalmente respiratorio e cardiovasomotorio). Sviluppo di aritmie cardiache, inclusa la fibrillazione ventricolare.
Squilibrio delle sostanze biologicamente attive e loro effetti
Manifestazioni: sintesi e rilascio compromessi di sostanze biologicamente attive di varie classi da parte delle cellule: neurotrasmettitori, ormoni, citochine, ecc. Interruzione dei processi di attivazione, inattivazione e consegna di sostanze biologicamente attive alle cellule bersaglio. Violazione dell'interazione di sostanze biologicamente attive con i loro recettori cellulari. Disturbo della risposta delle cellule bersaglio. Quest'ultimo è causato dal danneggiamento delle membrane cellulari e dei mediatori intracellulari degli effetti di ormoni, mediatori e citochine. Disintegrazione dei sistemi fisiologici e funzionali. Minimizzare le funzioni di organi e tessuti, il consumo di energia e i processi plastici. Transizione alla cosiddetta regolazione metabolica delle funzioni degli organi e dei tessuti. Questo di solito precede lo sviluppo di una condizione terminale.
Caratteristiche della patogenesi di alcuni stati comatosi
Le specificità dei singoli tipi di coma vengono solitamente rivelate nelle prime fasi del suo sviluppo. In queste fasi compaiono ancora le caratteristiche della causa del coma, nonché i collegamenti iniziali della sua patogenesi. Con l’aumentare della gravità degli stati comatosi, la loro specificità diminuisce e le loro caratteristiche comuni diventano sempre più evidenti.
Coma traumatico
Causa: lesione accompagnata da grave commozione cerebrale e perdita di coscienza. L'incoscienza durante un coma traumatico può durare da alcuni minuti a un giorno o più.
Manifestazioni: le risposte motorie e l'apertura degli occhi ad uno stimolo doloroso sono assenti o significativamente ridotte. Non si parla o il paziente emette suoni inarticolati. Ipo‑o areflessia. La respirazione e il ritmo cardiaco sono interrotti. La pressione sanguigna e il volume sanguigno si riducono, anche se non si è verificata alcuna perdita di sangue. Minzione involontaria. In connessione con contusione cerebrale, emorragie focali ed edema, vengono rilevati segni neuropatologici: paralisi (di solito emiparesi), riflessi patologici, disturbi della sensibilità locale, convulsioni. Il sangue si trova solitamente nel liquido cerebrospinale. Quando le ossa della base del cranio sono fratturate compaiono segni specifici: † sintomi di danno ai neuroni dei nuclei delle coppie VII e VIII di nervi cranici, † lividi nella zona orbitaria (sintomo di “occhiali”), † sanguinamento e fuoriuscita di liquido cerebrospinale dai condotti uditivi, dal naso, dalla bocca.
Coma apoplettico
Cause: emorragia cerebrale. Ischemia cerebrale locale acuta con conseguente infarto (con trombosi o embolia di una grande arteria cerebrale). Quest’ultima condizione è chiamata ictus (a causa del rapido aumento dei cambiamenti nel cervello e dell’interruzione del funzionamento del corpo).
Fattori di rischio: ipertensione arteriosa (soprattutto periodi di crisi ipertensive). Cambiamenti aterosclerotici nelle pareti dei vasi cerebrali.
Patogenesi
I principali fattori patogenetici del coma apoplessico sono: ischemia e ipossia del cervello (a causa di disturbi circolatori locali o estesi in esso), un aumento significativo della permeabilità delle pareti dei microvasi e un edema in rapido aumento della sostanza cerebrale. Un ictus è caratterizzato da disturbi circolatori secondari attorno all'area dell'ischemia cerebrale con segni in rapido aumento di perdita di sensibilità e movimento.
Manifestazioni
In caso di coma apoplessico a seguito di emorragia cerebrale: † il paziente perde improvvisamente conoscenza, † la sua faccia (nei casi tipici) è viola, † i vasi visibili sono dilatati e pulsano visibilmente, † le pupille non reagiscono alla luce, † i riflessi tendinei sono ridotti o assenti (iporeflessia), si osservano riflessi patologici ( Babinsky e così via.), † a causa del danno e dell'irritazione della sostanza cerebrale, i disturbi respiratori aumentano rapidamente (è rumoroso, rauco), † si osservano reazioni ipertensive e bradicardia.
Nel coma apoplessico a seguito di un ictus ischemico, di solito si osserva quanto segue: † disturbi della coscienza, fino alla sua perdita, † ipotensione arteriosa, † bradicardia, † aritmia cardiaca, † rara respirazione superficiale, † pelle e mucose pallide e fredde,
Conseguenze di emorragia cerebrale o ictus ischemico. Sono diversi e dipendono: dall’entità e dalla topografia del danno, dal grado di ipossia ed edema cerebrale, dal numero di lesioni, dalla gravità dell’ipertensione arteriosa, dalla gravità dell’aterosclerosi e dall’età del paziente.
Il coma apoplettico è uno degli stati comatosi più sfavorevoli, irto di morte o disabilità del paziente.
Coma ipocloremico
Causa Coma ipocloremico (cloroidropenico, cloroprivico) - una perdita significativa di sostanze contenenti cloro da parte dell'organismo. Ciò si osserva con: vomito ripetuto prolungato (in pazienti con intossicazioni endogene, intossicazioni alimentari, tossicosi della gravidanza, stenosi pilorica, ostruzione intestinale); trattamento improprio con diuretici, dieta a lungo termine priva di sale, insufficienza renale allo stadio poliurico, piccole fistole intestinali Considerando che nelle condizioni sopra indicate Cl – , Na + e K + si perdono in modo relativamente lento, così come gli effetti compensatori di. meccanismi adattativi, il coma si sviluppa gradualmente nei casi tipici.
Manifestazioni: formazione compromessa di MP e AP a causa della diminuzione del contenuto di Na+, K+, Cl – e di alcuni altri ioni nel plasma sanguigno, nei fluidi intercellulari e in altri fluidi biologici. Disturbi dell'eccitabilità cellulare. Violazioni delle funzioni cellulari specifiche e non specifiche. In conseguenza di ciò si sviluppano: † debolezza muscolare, † ipoidratazione. A causa della perdita di liquidi da parte del corpo: ‡ pelle secca e mucose, ‡ il turgore dei tessuti è ridotto, ‡ i lineamenti del viso sono affinati, ‡ lingua secca ‡ si sviluppa oliguria ‡ Ht è notevolmente aumentato, ‡ La pressione sanguigna è solitamente ridotta ‡ BCC è ridotto, ‡ squilibrio ionico, ‡ interruzione dell’afflusso di sangue al cervello.
L'ischemia cerebrale, aumentando di entità e grado, provoca progressivi disturbi della coscienza: lo stato di stupore si trasforma in ritardo psicomotorio e termina con la perdita di coscienza.
Metodi di trattamento per gli stati comatosi
Il trattamento etiotropico è il principale. Determina in gran parte la prognosi delle condizioni del paziente. A questo proposito, vengono adottate misure per fermare o indebolire l'effetto patogeno del fattore causale.
† Per il coma traumatico:
‡ il fattore dannoso viene eliminato,
‡ antidolorifici, anestetici locali,
‡ se necessario, anestesia.
† Per il coma causato da intossicazione del corpo, utilizzare:
‡ antidoti specifici,
‡ antitossine,
‡ lavanda gastrica,
‡ diuretici.
† Per il coma diabetico:
‡ somministrare la dose calcolata di insulina,
‡ se necessario, contemporaneamente alla soluzione di glucosio (per prevenire il coma ipoglicemico).
† Per coma di origine infettiva: utilizzare agenti antibatterici (antibiotici, sulfamidici e antisettici che agiscono sulla flora dell'intestino e delle vie urinarie).
La terapia patogenetica è fondamentale nel trattamento di qualsiasi paziente in coma.
Comprende misure volte a bloccare, eliminare e/o ridurre gli effetti dannosi dei principali collegamenti nella patogenesi del coma: ipossia, intossicazione, disturbi ASH, squilibrio di ioni e liquidi, sostanze biologicamente attive e loro effetti.
† Terapia antiipossica
‡ Miscele di gas respirabili con un elevato contenuto di ossigeno.
‡ Ossigenazione iperbarica.
‡ Introduzione di antiossidanti (ad esempio preparati di glutatione, selenio, SOD, catalasi, ubichinone e altri).
‡ Normalizzazione della funzione cardiaca e del tono vascolare.
† Eliminazione o riduzione del grado di intossicazione del corpo mediante:
‡ Trasfusioni di sangue, plasma e sostituti del plasma, soluzione fisiologica di cloruro di sodio.
‡ Introduzione di soluzioni contenenti composti organici di grandi dimensioni molecolari: poliglucina, reopopiglyukin e altri. Questi farmaci sono combinati con diuretici per stimolare l'eliminazione dal corpo dei liquidi e delle sostanze tossiche in essi contenute.
‡ Nei casi gravi, così come nell'insufficienza renale, coma uremico - emodialisi e dialisi peritoneale.
† Normalizzazione degli indicatori ASR, equilibrio ionico e liquido attraverso:
‡ Introduzione controllata nel corpo di soluzioni tampone con il contenuto e il rapporto richiesti (per ogni paziente questo viene selezionato individualmente, tenendo conto dei dati di laboratorio) di vari ioni.
‡ Trasfusioni di sangue, plasma, sostituti del plasma.
† Normalizzazione del livello di sostanze biologicamente attive e dei loro effetti. A questo scopo utilizzare:
‡ ormoni surrenalici (gluco- e mineralcorticoidi, steroidi androgeni, catecolamine),
‡ ormoni pancreatici (insulina, glucagone),
‡ neurotrasmettitori (acetilcolina, norepinefrina), ecc.
Questi farmaci normalizzano le funzioni del cuore, dei reni, del cervello e di altri organi, indicatori dell'omeostasi e attivano reazioni adattative specifiche e non specifiche del corpo.
La terapia sintomatica ha lo scopo di ottimizzare le funzioni degli organi e dei loro sistemi, eliminando crampi, dolore e sensazioni dolorose negli stati pre e post comatosi. A questo scopo utilizzare:
† anticonvulsivanti,
† antidolorifici (compresi narcotici),
† farmaci cardiotropi e vasoattivi,
† analettici respiratori.
Considerando che il coma è caratterizzato da gravi disturbi delle funzioni degli organi, dei loro sistemi e dei meccanismi di regolazione del corpo, l'efficacia delle misure terapeutiche dovrebbe essere monitorata registrando costantemente lo stato delle funzioni vitali (attività cardiaca, respirazione, funzione escretoria del i reni, ecc.), coscienza e parametri di omeostasi.
Coma chiamato stato inconscio con una profonda compromissione dei riflessi e mancanza di risposta alla stimolazione.
Nella patogenesi degli stati comatosi, i disturbi circolatori nel cervello e il danno tossico alle cellule del sistema nervoso centrale sono di primaria importanza.
Molto spesso, gli stati comatosi si osservano in incidenti cerebrovascolari acuti, diabete mellito, nefrite cronica, aumento dell'insufficienza epatica e avvelenamento grave.
Il sintomo generale e principale di un coma di qualsiasi origine è una profonda perdita di coscienza causata da danni alle parti vitali del cervello.
Il coma può svilupparsi improvvisamente nel bel mezzo di un relativo benessere. Lo sviluppo acuto è tipico del coma cerebrale durante l'ictus, coma ipoglicemico.
Tuttavia, in molti casi, uno stato comatoso, che complica il decorso della malattia, si sviluppa gradualmente (con coma diabetico, uremico, epatico e molti altri stati comatosi).
In questi casi il coma, una profonda perdita di coscienza, è preceduto da uno stadio di precoma. Sullo sfondo di una crescente esacerbazione dei sintomi della malattia di base, compaiono segni di danno al sistema nervoso centrale sotto forma di stupore, letargia, indifferenza, confusione con schiarimenti periodici.
Tuttavia, durante questo periodo, i pazienti mantengono la capacità di rispondere a forti irritazioni, tardivamente, a monosillabi, ma rispondono comunque a una domanda posta ad alta voce e mantengono i riflessi pupillari, corneali e di deglutizione;
La conoscenza dei sintomi di uno stato precomatoso è particolarmente importante, poiché spesso la fornitura tempestiva di assistenza durante questo periodo della malattia impedisce lo sviluppo del coma e salva la vita del paziente.
Quando si esamina la pelle, si dovrebbe tenere conto del fatto che con uremia, trombosi dei vasi cerebrali e anemia, la pelle è pallida. Nel coma alcolico o nell'emorragia cerebrale, il viso è solitamente iperemico. La colorazione rosa della pelle è caratteristica del coma dovuto ad avvelenamento da monossido di carbonio. Il giallo della pelle si osserva solitamente nel coma epatico.
È importante determinare il contenuto di umidità della pelle di un paziente in coma. La pelle umida e sudata è caratteristica di un coma ipoglicemico. In un coma diabetico, la pelle è sempre secca. Tracce di vecchi graffi sulla pelle possono essere notate in pazienti in coma diabetico, epatico e uremico.
I foruncoli freschi, così come le cicatrici cutanee di vecchi foruncoli, riscontrati in pazienti in coma, fanno pensare al diabete.
Di particolare importanza è lo studio del turgore cutaneo. In alcune malattie accompagnate da disidratazione del corpo e che portano allo sviluppo del coma, si osserva una significativa diminuzione del turgore della pelle. Questo sintomo è particolarmente pronunciato nel coma diabetico.
Una simile diminuzione del turgore dei bulbi oculari nel coma diabetico li rende morbidi, cosa che può essere facilmente determinata dalla palpazione.
Quando si esamina le mucose, è necessario prestare attenzione al colore e al grado di umidità. Il giallo della sclera viene solitamente rilevato nel coma epatico e nell'anemia.
Quando si esamina la lingua, la presenza di morsi freschi e cicatrici di vecchi morsi dovrebbe suggerire l'epilessia. Il coma uremico è caratterizzato da un'insolita secchezza della lingua.
Un grave gonfiore del tessuto sottocutaneo può essere rilevato in pazienti con coma uremico ed epatico. In quest'ultimo caso, l'edema è combinato con l'ascite.
Uno stato comatoso è caratterizzato da una violazione del ritmo respiratorio. Nel coma diabetico ed epatico si osserva spesso un respiro ampio e rumoroso di Kussmaul. Con il coma cerebrale, di solito appare la respirazione russante (stertorosa). Spesso, nei pazienti in coma, si osserva la respirazione di Cheyne-Stokes con un graduale aumento e quindi un indebolimento della profondità dei movimenti respiratori fino alla comparsa di una pausa nei movimenti respiratori (periodo di apnea).
Determinare l'odore dell'aria espirata da un paziente ha un importante valore diagnostico. Il coma uremico è caratterizzato dall'odore di ammoniaca, a volte così forte da attirare l'attenzione già entrando nella stanza in cui giace il paziente.
Se senti odore di alcol o di vodka dalla bocca, non dovresti escludere l'origine alcolica del coma. Nel coma diabetico, nell'aria espirata si rileva quasi sempre l'odore dell'acetone, che ricorda l'odore delle mele leggermente mature.
Lo studio del polso e della pressione sanguigna nei pazienti in coma è di grande importanza. Bradicardia con tensione del polso e ipertensione si osserva nell'eclampsia e nelle fasi iniziali del coma cerebrale.
L'elevata ipertensione arteriosa viene solitamente rilevata nei pazienti in coma uremico. Nel coma diabetico si determinano bassa pressione sanguigna e tachicardia.
Il rilevamento di gravi sintomi neurologici sotto forma di emiplegia o emiparesi indica un incidente cerebrovascolare acuto come causa del coma.
In ogni caso di coma, il paziente deve essere immediatamente chiamato un medico.
Trattamento del coma dipende dalla natura della malattia di base.
In coma diabetico Al paziente viene somministrata insulina sottocutanea ed endovenosa, bicarbonato di sodio e soluzione salina come prescritto dal medico.
Coma ipoglicemico preceduto da una sensazione di fame, debolezza e tremore in tutto il corpo. Prima dell'arrivo del medico, al paziente viene somministrato zucchero o tè dolce. 20-40 ml di una soluzione di glucosio al 40% vengono iniettati in una vena.
Con coma uremico le misure terapeutiche mirano a ridurre l'intossicazione. A tale scopo viene somministrato un clistere detergente, viene iniettata goccia a goccia una soluzione isotonica di cloruro di sodio e una soluzione di glucosio al 5%.
Con coma epatico Come prescritto dal medico, le soluzioni di glucosio, gli ormoni steroidei e le vitamine vengono somministrate tramite flebo.
Leggi anche...
- Presentazione sul tema "Paesi africani" Presentazione sul tema qualsiasi paese africano
- Interconnessione di problemi globali
- Analisi del sistema di gestione della motivazione in un'agenzia di viaggi. Metodi di gestione della motivazione del personale nelle imprese turistiche
- Analisi del rapporto tra entrate, spese e risultati finanziari Rapporto tra profitti e spese